Note di Giovanni Patrizi.
1. Potere disciplinare. Contestazione dell’addebito.
Il datore di lavoro esercita il potere direttivo e il potere disciplinare, vale a dire il potere di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti che non seguano le direttive impartite.
I comportamenti sanzionabili sono di norma contenuti nei contratti collettivi (CCNL) o nei regolamenti aziendali.
Il potere disciplinare dev’essere esercitato attraverso una procedura che (per il settore privato) è contenuta nello Statuto dei lavoratori (art. 7, L. 300/1970) e che vincola tutti i datori qualunque sia la dimensione dell’azienda o dell’impresa.
L’art. 7 St. lav. stabilisce che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa prima avergli contestato l’addebito e senza averlo sentito a difesa.
Unica eccezione a questa regola generale è costituita dal rimprovero verbale.
Il datore di lavoro è obbligato, prima di adottare una sanzione, a specificare l’illecito e a consentire al lavoratore di fornire le sue giustificazioni.
I contratti collettivi definiscono le sanzioni disciplinari, graduandole a seconda della gravità dell’infrazione.
Le sanzioni possono essere conservative (del rapporto di lavoro) o non conservative.
Fra le sanzioni conservative rientrano:
– il rimprovero verbale (non necessita del rispetto della procedura);
– il rimprovero scritto (o ammonizione o biasimo);
– la multa, che non può essere superiore all’equivalente di 4 ore di retribuzione base;
– la sospensione dal servizio e della retribuzione per non più di 10 giornate.
Costituisce invece sanzione non conservativa il licenziamento disciplinare.
2. Codice disciplinare
Il codice disciplinare è l’insieme delle norme disciplinari (infrazioni, sanzioni) previste dalla contrattazione collettiva o in mancanza da un regolamento aziendale (o dal datore di lavoro).
Se il datore intende sanzionare un particolare comportamento, deve specificarlo nel codice disciplinare.
Se il codice disciplinare è generico, cioè non chiarisce i comportamenti vietati e le sanzioni correlate, i provvedimenti disciplinari sono nulli.
Il codice dev’essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Non sono consentite forme di pubblicità equivalente (Cass. civ., 1208/1988; Cass. 18130/2005).
Secondo la Corte dio Cassazione, se il comportamento contestato (e sanzionato) è immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere alla pubblicità del codice disciplinare (es. il furto di beni aziendali sarà punibile anche se non previsto dal codice disciplinare: Cass. 54/2017; per l’utilizzo scorretto del congedo parentale, v. Cass. 6893/2018 e successive).
3. Forma della contestazione disciplinare
La contestazione disciplinare dev’essere effettuata in forma scritta. In difetto la contestazione (e l’intera procedura disciplinare) deve considerarsi invalida.
Il contenuto non è sottoposto a formule precise: è sufficiente che la comunicazione specifichi il fatto contestato nei suoi aspetti essenziali.
La contestazione disciplinare è un atto di natura recettizia: il datore di lavoro deve provare la consegna del documento al lavoratore.
Di norma si ritiene conosciuta la contestazione che perviene all’indirizzo del destinatario se quest’ultimo non prova di esser stato impossibilitato, senza colpa, a riceverla (art. 1335 c.c.). In caso di utilizzo del sistema postale basta esibire l’avviso di ricevimento o giacenza.
4. Specificità
La contestazione dell’addebito dev’essere specifica, nel senso che dev’esser capace di rendere noto al lavoratore il fatto contestato, nei suoi aspetti essenziali. Questa caratteristica è fondamentale perché consente al lavoratore di comprendere il fato e formulare le sue difese.
Anche in questo caso non esistono formule prestabilite: il fatto dev’essere descritto in modo comprensibile e dev’esser chiara la volontà del datore di lavoro di considerarlo illecito. Spetta al Giudice verificare se la descrizione degli eventi è stata effettuata con correttezza e se la mancanza di determinati elementi abbia leso il diritto di difesa del lavoratore (Cass. 6889/2018 e successive).
Per esemplificare: sé certamente necessario indicare il luogo e il tempo della presunta infrazione, mentre non devono essere dettagliate le norme di legge o contrattuali che il datore ritenga violate.
Il requisito della specificità è soddisfatto anche quando, per descrivere l’illecito, si faccia riferimento ad un diverso atto (per esempio penale) già in possesso del dipendente (c.d. contestazione per relationem; Cass. civ. 29240/2017; Cass. 10662/2014 e successive).
La recidiva (cioè la ripetizione nel tempo dell’illecito) acquista rilevanza quando la reiterazione dell’inadempimento diventa elemento costitutivo della fattispecie (ad es. alcuni CCNL prevedono l’applicazione del licenziamento disciplinare in caso di recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto).
L’ultimo comma dell’art. 7 St. lav. afferma che “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Trascorsi due anni, dunque, i comportamenti sanzionati perdono autonomo rilievo ma possono essere citati, quali circostanze che confermano la significatività degli addebiti mossi, ai fini di una valutazione complessiva della condotta attuale del dipendente (Cass. 14433/2017 e successive).
Anche per la recidiva vige il principio di specificità: il datore di lavoro deve chiaramente indicare quali fatti intende contestare nell’arco del biennio, pena la nullità della sanzione (Cass. civ., sez. lav., 25 Gennaio 2018, n. 1909).
5. Immediatezza
La contestazione dovrebbe essere emessa subito dopo che il fatto è avvenuto o dopo che il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
La giurisprudenza tuttavia interpreta questo requisito in senso relativo: si deve infatti considerare il tipo di infrazione e concedere un certo margine di tempo per il suo accertamento senza tuttavia consentire una dilazione tale da vanificare il diritto di difesa del dipendente. Si pensi al caso di una struttura aziendale complessa: può ragionevolmente esservi un rilevante intervallo fra a) il momento in cui l’illecito viene commesso; b) quello in cui il datore ne ha notizia e, c) quello in cui sono stati raccolti tutti gli elementi (documenti, testimonianze) necessari a formulare la contestazione.
Al contrario, il datore di lavoro non può contestare fatti risalenti nel tempo senza dedurre legittimi motivi di impedimento o ritardo (Cass. 16841/2018).
Se il fatto contestato è di difficile accertamento e costituisce anche illecito penale, il datore di lavoro può legittimamente attendere l’esito delle indagini anziché svolgere una propria inchiesta (Cass. 12788/2019).
In caso di violazione del principio di immediatezza la sanzione irrogata è illegittima.
6. Immodificabilità
La contestazione è immutabile. Il datore di lavoro non può modificare “in corsa” le imputazioni. Pertanto, vi dev’essere corrispondenza fra il fatto posto a base della contestazione e il fatto posto alla base della successiva sanzione. Questa corrispondenza deve riguardare solo gli eventi materiali e non la loro qualificazione, cioè la valutazione dal punto di vista giuridico (Cass. 26678/2017; Cass. 2935/2013).
In particolare il datore non può far valere circostanze nuove rispetto a quelle inizialmente indicate, in modo da variare la contestazione.
Sono invece ammissibili chiarimenti o correzioni di elementi secondari, tali da non stravolgere l’evento contestato nel suo complesso.
È anche legittimo citare fatti non contestati e risalenti nel tempo, se confermano la gravità degli addebiti posti alla base del provvedimento sanzionatorio, perché consentono di valutare complessivamente le inadempienze e la proporzionalità della sanzione irrogata (Cass. 14453/2017).
È importante ricordare il divieto del ne bis in idem, che consiste nel divieto di sottoporre per due volte il lavoratore a procedimento disciplinare per i medesimi fatti (Cass. 10343/2019).
Peraltro, il principio della immutabilità non impedisce al datore di lavoro, nei casi di contemporanea pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti contestati, di utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l’addebito, sempre nell’ambito di quello originario, e purché al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse precisate (Cass.11868/2016).
In caso di violazione del principio di immodificabilità la sanzione è illegittima.
7. La difesa del lavoratore.
Il lavoratore che riceve una contestazione disciplinare può presentare le proprio giustificazioni (art. 7, L. 300/1970). Si tratta di una mera facoltà; pertanto, l’eventuale silenzio non pregiudica future impugnazioni (davanti al Giudice).
La legge non prevede un obbligo del datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione dell’incolpato la documentazione aziendale alla base dell’addebito. Essa dev’esser tuttavia fornita su richiesta del lavoratore in base ai principi di correttezza e buona fede e nei limiti del necessario per predisporre un’efficace difesa (Cass. 6337/2013).
8.. Il termine a difesa
L’art. 7, St. lav., prevede che nessun provvedimento disciplinare, eccetto il rimprovero verbale, possa essere irrogato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto dei fatti.
Il lavoratore ha dunque 5 giorni di tempo dal momento della contestazione per presentare eventuali giustificazioni.
È bene ricordare che il CCNL applicato al rapporto di lavoro può prevedere un termine maggiore.
Anche le difese del lavoratore sono un atto recettizio e devono quindi pervenire nella sfera di conoscenza del datore entro il suddetto termine: la scadenza quindi non può ritenersi rispettata se le osservazioni, pur inviate prima del decorso, giungano a destinazione dopo il compimento dei 5 giorni. Altra questione, in passato molto dibattuta, è quella se sia possibile per il datore irrogare il provvedimento disciplinare a giustificazioni ricevute ma prima che sia esaurito il termine a difesa di 5 giorni (es. il lavoratore si è giustificato per iscritto il giorno successivo alla contestazione ed il terzo giorno il datore di lavoro irroga la sanzione).
La Cassazione ha affermato che la sanzione può essere legittimamente irrogata prima della scadenza del termine di 5 giorni quando il lavoratore ha esercitato il suo diritto di difesa facendo pervenire le proprie giustificazioni, senza manifestare riserve su ulteriori difese (Cass. Sezioni Unite, 6900/2003; Cass. n. 3129/2015 e successive).
Per il computo del termine di 5 giorni si deve tener conto dei giorni di calendario e non dei giorni lavorativi, mettendo nel calcolo anche i giorni festivi intermedi.
9. L’audizione orale
Il lavoratore ha diritto di essere sentito personalmente a propria difesa se lo richiede espressamente. Tale facoltà può permanere anche in presenza di difese scritte.
Il datore di lavoro che voglia adottare una sanzione non può rifiutare l’audizione del lavoratore che nel termine dei 5 gg. ne abbia fatto espressa richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive (Cass. n. 11895/2017; n. 204/2017).
È legittimo che l’audizione si svolga nel corso di un colloquio informale e con la presenza di un soggetto abilitato a rappresentare il datore di lavoro se il lavoratore ha avuto la possibilità di formulare le proprie deduzioni (Cass. 476/1998).
Alcune precisazioni:
-non esiste un obbligo del datore di lavoro di consentire il diritto di difesa alle condizioni poste dal dipendente;
-non sono necessarie particolari formalità né la redazione di un verbale, che tuttavia sarà di utilità per il datore al fine di dimostrare l’avvenuto incontro;
-il lavoratore, per legge, ha diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale ma non dal proprio avvocato (Cass.6994/2018). Il rappresentante sindacale appartiene all’associazione cui il lavoratore appartiene o conferisce il mandato.
Non esiste diritto del lavoratore al differimento della data di audizione se non per oggettive ragioni che rendono impossibile la presenza (Cass. 8845/2012).
10. La sanzione disciplinare
Una volta provveduto alla contestazione ed (eventualmente) ricevuto le giustificazioni, il datore di lavoro può adottare il provvedimento disciplinare.
Come sopra accennato i provvedimenti disciplinari adottabili sono:
rimprovero scritto
multa (che non può essere superiore a 4 ore di retribuzione);
sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a 10 giornate)
11. Tempestività della sanzione
L’art. 7 St. lav. non prevede un termine “finale” entro cui la sanzione debba essere adottata. La giurisprudenza tuttavia ritiene che l’irrogazione debba essere tempestiva: il datore, infatti, non deve indugiare nella sua decisione.
Tale esigenza è particolarmente evidente nel caso in cui si intenda licenziare il dipendente per giusta causa: una eccessiva attesa contrasterebbe con il presupposto della motivazione adottata (causa che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto: art. 2119 c.c.).
Anche la contrattazione collettiva ha un peso in materia.
Alcuni CCNL prevedono esplicitamente un termine per l’irrogazione della sanzione disciplinare oltre il quale si presume che il datore abbia accettato tacitamente le giustificazioni fornite dal lavoratore.
La sanzione adottata non tempestivamente e comunque oltre il termine stabilito dalla contrattazione collettiva è illegittima.
12. Proporzionalità della sanzione
La sanzione deve essere proporzionale alla gravità del fatto tenendo conto di tutte le circostanze: sia quelle soggettive (attinenti alla persona) sia quelle oggettive (attinenti al fatto) che hanno caratterizzato la commissione dell’illecito.
Il giudizio sull’accertamento del fatto, sulla gravità del medesimo, sulla proporzionalità della reazione sanzionatoria rispetto alla condotta spetta al Giudice ed è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
In alcuni casi la contrattazione collettiva prevede specificamente che determinate condotte diano luogo a specifiche sanzioni.
In tali casi il datore di lavoro può applicare sanzioni meno severe rispetto a quelle astrattamente previste, mentre non può adottare misure più gravi rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
La deroga, nel primo caso, si spiega poiché la scelta del datore è favorevole al dipendente.
13. Efficacia della sanzione
Una volta irrogata e portata a conoscenza del lavoratore la sanzione disciplinare è immediatamente efficace.
14. Sospensione cautelare
Il datore di lavoro ha la facoltà di sospendere “cautelarmente” dal servizio il lavoratore durante lo svolgimento del procedimento disciplinare.
La sospensione cautelare è diversa ovviamente dalla “sospensione finale” (che è invece una sanzione in senso stretto). Alla prima non si applicano quindi le garanzie del procedimento disciplinare (Cass. 3076/2016).
Con la sospensione cautelare il datore di lavoro esonera il dipendente dalla prestazione in vista di un probabile licenziamento, pur dovendo ancora acquisire tutti gli elementi e considerando comunque deleteria la prosecuzione della prestazione nelle more degli accertamenti.
La sospensione cautelare evita la presenza in azienda del lavoratore fino al licenziamento ma non lo priva del diritto alla retribuzione.
15. Sedi di impugnazione delle sanzioni disciplinari e relative procedure
Il lavoratore che subisca un provvedimento disciplinare può impugnarlo sia per ragioni formali che per ragioni sostanziali.
Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento può essere impugnato essenzialmente quando il dipendente contesti la veridicità dei fatti o, comunque assuma la sua estraneità dai medesimi. Il provvedimento, può essere poi impugnato sotto un profilo formale, quando il datore di lavoro non abbia seguito le procedure indicate dall’art. 7 della Legge 300/1970 e dal contratto collettivo (per esempio erogando la sanzione dopo il termine massimo previsto dal contratto).
Anche la mancata affissione del regolamento disciplinare determina l’illegittimità formale del provvedimento, che non può essere nemmeno ripetuto o rinnovato proprio perché mancava l’affissione.
Nell’ipotesi di provvedimento disciplinare intimato senza la contestazione scritta del fatto al lavoratore, oppure senza consentire la difesa a mezzo del rappresentante dell’associazione sindacale (commi due e tre dell’art. 7 della Legge 300/1970) il provvedimento è illegittimo sotto il profilo formale, ma il datore di lavoro potrà rinnovare la contestazione.
Il lavoratore può impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro oppure davanti al collegio di conciliazione ed arbitrato oppure davanti a collegi di conciliazione previsti dai contratti.
Il lavoratore, al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto, ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite Direzione provinciale del lavoro (DPL), di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro.
Il lodo emesso dal Collegio non è impugnabile tranne nei casi di violazione della legge e di vizio della volontà.
Va sottolineato che l’iniziativa di adire il Collegio di conciliazione ed arbitrato è riservata al lavoratore ma deve essere ricevuta dal datore di lavoro.
Quest’ultimo, infatti, potrebbe non aderire alla richiesta di costituzione del Collegio; in tal caso è suo onere attivare la richiesta di convocazione presso la Commissione di conciliazione istituita presso la DPL ai sensi dell’art. 410 c.p.c.
Se il datore di lavoro si limita invece a non indicare il proprio membro in seno al Collegio entro il termine di dieci giorni da quando viene notificata la richiesta da parte della DPL, il provvedimento disciplinare automaticamente decade.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora, il datore non provveda entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, il provvedimento disciplinare viene automaticamente annullato.
Qualora, invece, il datore di lavoro si rivolga al magistrato, la sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla definizione del giudizio.
Nel caso in cui sia il lavoratore a promuovere l’azione giudiziaria, l’applicazione della sanzione non è sospesa.
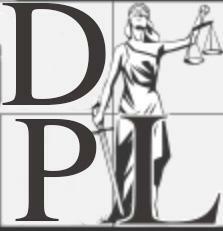
Commenti recenti