Settanta anni fa, il 18 aprile del 1955, moriva Albert Einstein, che l’autorevole Physics World (pubblicazione del prestigioso Institute of Physics di Londra) avava indicato come “il più grande Fisico di tutti i tempi”.
Quando Einstein divenne universalmente famoso, quando cioè iniziò a delinearsi quell’icona della scienza e dell’intelligenza che noi oggi conosciamo, il quotidiano New York Times scrisse che i suoi lavori potevano essere capiti solo da una dozzina di uomini in tutto il mondo. Cent’anni dopo, le due teorie della relatività -la relatività ristretta del 1905 e la relatività generale del 1915, poi pubblicata nel 1916- sono entrate a pieno diritto nel sapere comune e persino nella nostra vita quotidiana. Le idee proposte in quegli scritti originali, all’inizio del Novecento -orologi che rallentano il loro corso, spazi che si deformano, raggi luminosi che si piegano- non sono più appannaggio di pochi, sono a tutti gli effetti parte integrante della nostra vita. Pochissimi scienziati potrebbero vantare un primato simile.
Che un lascito così imponente sia stato concepito in poche pagine, in due soli articoli scientifici, è poi doppiamente notevole, così come è quasi incredibile che ancora oggi -a distanza di oltre un secolo- nelle università di tutto il mondo si insegni la teoria einsteiniana sulla falsariga di quei due articoli originali[1].
Gli anni dal 1902 al 1909 furono tra i più intensi per la produzione scientifica di Albert Einstein (nato il 14 marzo 1879 a Ulm, nel Baden-Württemberg).
La scoperta dei fondamenti della teoria speciale della relatività gli valse nel 1912 la nomina a professore ordinario di matematiche superiori nel politecnico di Zurigo. Nel 1914 fu chiamato a dirigere il Kaiser-Weilhelm-Institut per la fisica.
Nel 1921 conseguì il premio Nobel “per i suoi contributi alla fisica teorica e in particolare per la scoperta dell’effetto fotoelettrico”, come recita la motivazione.
Nel 1933 le persecuzioni politiche e razziali lo indussero a lasciare l’Europa. Emigrò negli Stati Uniti ed entrò a far parte dell’Institute for Advanced Studies di Princeton.
Morì il 18 aprile 1955.
La grandezza di Einstein consiste nell’avere cambiato in maniera radicale le metodologie di interpretazione del mondo della fisica. Il suo contributo fu rilevante in campo scientifico ma la sua riflessione si estese anche all’ambito filosofico. La riflessione “non scientifica” accompagnò tutta la sua esistenza e mise in luce il suo spirito libero, la sua apertura verso il mondo e la sua costante ricerca del significato della realtà[2].
A conclusione di queste brevi note, riportiamo il giudizio sull’opera di Einstein espresso da un grande fisico francese, Louis de Broglie, cui si devono, fra l’altro, le idee nuove che stanno alla base della meccanica ondulatoria: “Per tutti gli uomini colti, siano essi o meno votati a qualche ramo della Scienza, il nome di Albert Einstein evoca lo sforzo intellettuale geniale, che capovolgendo i dati più tradizionali della fisica è riuscito a stabilire la relatività delle nozioni di spazio e di tempo, la inerzia dell’energia e l’interpretazione in qualche modo puramente geometrica delle forze di gravitazione. È infatti questa un’opera ammirevole, paragonabile alle più grandi opere che s’incontrano nella storia delle scienze, ad esempio quella di Newton; di per se stessa, basterebbe ad assicurare al suo autore una gloria imperitura”.
[1] Si v. “Le due relatività. Gli articoli del 1905 e 1916” (Trad. it. di Aldo M. Pratelli, Ermanno Sagittario. Prefazione di Vincenzo Barone), Ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2015. Di Einstein, l’Ed. Bollati Boringhieri ha pubblicato anche Autobiografia scientifica (2014), Il significato della relatività (2014), Pensieri degli anni difficili (2014), Relatività. Esposizione divulgativa (2011, edizione del Centenario, 2015), L’evoluzione della fisica (assieme a Leopold Infeld, 2011), Lettere d’amore (assieme a Mileva Maric, 1993) e Perché la guerra? Riflessioni a due sulle sorti del mondo (insieme a Sigmund Freud, 2006).
[2] Si v. A. Einstein, “Mein Weltbild”, Querido Verlag, Amsterdam 1934 (trad. it. Remo Valori, “Come io vedo il Mondo”, Newton Compton Editori, Bologna 1993. Il libro comprende alcuni capitoli (La questione del metodo, Evoluzione della fisica: Kepler e Newton, Evoluzione del concetto di realtà fisica) nei quali l’A. descrive il mutamento avvenuto nel corso della storia in relazione a quelle che si ritenevano certezze sul reale fisico.
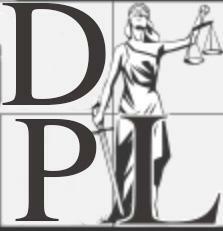
Commenti recenti