di Giovanni Patrizi
1.La Corte penale internazionale (di seguito CPI) è un tribunale chiamato a giudicare i responsabili di crimini particolarmente efferati che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.
Occorre ricordare in proposito che l’Italia ospitò nel luglio del 1998 la Conferenza diplomatica che condusse il 17 luglio del 1998 all’adozione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, che per questo è noto anche come “Statuto di Roma”,.
L’Italia ha dunque svolto un ruolo essenziale e di supporto alla creazione di tale istituzione, è stata il primo paese firmatario del trattato istitutivo della Corte ed uno dei primi a depositare lo strumento di ratifica di tale trattato (con Legge 26 luglio 1999, n. 232).
La CPI, che ha sede all’Aia, rappresenta la prima giurisdizione penale sovranazionale indipendente, permanente e con competenza non retroattiva.
Essa, infatti, a differenza dei Tribunali ad hoc per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda, non è un organo dell’Onu ed il suo Procuratore è svincolato dal controllo degli Stati.
La Corte Penale Internazionale è dunque un tribunale internazionale permanente ma con giurisdizione limitata. Essa opera per mantenere la giustizia nella comunità internazionale quando vengano commessi crimini specifici per i quali è competente secondo lo Statuto di Roma.
Il trattato istitutivo della Corte penale internazionale è entrato in vigore nel luglio 2002, al raggiungimento della sessantesima ratifica.
I Paesi che riconoscono la giurisdizione della Corte Penale Internazionale e che hanno ratificato il suo Statuto sono 125 e tra questi ci sono tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Come anticipato, l’Italia ha ratificato lo Statuto di Roma nel 1999.
Tra i Paesi che non riconoscono la giurisdizione della Corte Penale Internazionale ci sono: Russia, Cina, India, Israele, Iran, Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Stati Uniti: nel corso dei negoziati gli USA avevano presentato, senza successo, una proposta che mirava a introdurre, tra le condizioni di esercizio della giurisdizione della CPI, l’accettazione della giurisdizione stessa da parte dello stato di nazionalità dell’accusato.
2.Lo Statuto di Roma, stipulato il 17 luglio del 1998, definisce in dettaglio la giurisdizione e il funzionamento della CPI. In particolare, lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell’attività giurisdizionale in materia e disciplina le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell’esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.
La Corte ha il potere di giudicare individui, capi di stato e di governo o privati, che abbiano commesso genocidio (distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso), crimini contro l’umanità (omicidio, deportazione, tortura e altri perpetrati come parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro una popolazione civile), crimini di guerra (violazioni del diritto internazionale umanitario come gli attacchi intenzionalmente diretti contro popolazioni e obiettivi civili, che fanno parte di un programma politico o hanno luogo su larga scala). Lo Statuto prevede anche i crimini contro la pace (aggressione), ma la giurisdizione in materia è subordinata all’introduzione di una definizione di aggressione in una futura modifica dello Statuto stesso.
La CPI è una corte di ultima istanza che non può essere adita se il caso è oggetto di un procedimento giudiziario nazionale. Inoltre, in base al principio di complementarità, la giurisdizione della CPI può esercitarsi solo quando lo stato che ha la giurisdizione sul caso non abbia la volontà o la capacità di attivarsi. La giurisdizione della Corte non ha tuttavia carattere universale, ma è condizionata ad alcuni fattori: l’imputato è un cittadino di uno stato membro o di uno stato che accetta la giurisdizione della Corte, il reato ha avuto luogo nel territorio di uno stato membro o di uno stato che accetta la giurisdizione della Corte, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affidato il caso al procuratore a prescindere dalla nazionalità dell’imputato e dal luogo del crimine e quindi non è necessario il consenso dello stato.
Il procuratore può decidere di avviare un’indagine sulla base di un mandato di uno stato membro, o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero d’ufficio sulla base di informazioni ricevute da individui o organizzazioni
La CPI esercita le proprie funzioni ed i propri poteri sul territorio di qualsiasi Stato Parte ma, mediante una apposita convenzione a tal fine, la sua giurisdizione può estendersi al territorio di ogni altro Stato che ne faccia richiesta.
Quando un determinato crimine è entrato a far parte del diritto internazionale consuetudinario, la giurisdizione della Corte è estesa anche agli Stati non firmatari della Convenzione di Roma. E’ il caso ad esempio del genocidio, inteso come “l’’atto commesso nell’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.
3.Solo nel 2012, tredici anni dalla ratifica dello Statuto di Roma, con L. n. 232/1999, il Parlamento italiano ha approvato la legge 20 dicembre 2012 n. 237, recante “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale” . All’iniziale sollecitudine e all’iniziale ruolo attivo dell’Italia sono seguiti vari anni di sostanziale inerzia.
Questa legge, tralasciando la parte relativa al diritto penale sostanziale, disciplina gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra la giurisdizione italiana e quella della CPI. Essa riguarda solo la cooperazione giudiziaria e l’esecuzione interna dei provvedimenti della Corte, e introduce nel codice penale italiano i reati contro l’amministrazione della CPI così come previsto dall’art. 70 dello Statuto di Roma.
Si tratta di un testo relativamente semplice che, in ragione della dimensione “verticale” che caratterizza il rapporto di cooperazione con la CPI, elide o ridimensiona alcuni degli elementi classicamente presenti nel contesto di forme di cooperazione “orizzontali”, tipiche dei rapporti tra Stati. Per tutto ciò che L. n. 237/2012 non prevede espressamente, si rinvia alle previgenti disposizioni in materia di estradizione, rogatorie internazionali ed effetti delle sentenze penali straniere .
In particolare, sono due gli aspetti presi in considerazione dalla legge: a) la cooperazione giudiziaria dell’Italia con la Corte e, b) l’esecuzione interna dei provvedimenti della Corte, incluse le sentenze di condanna.
La legge n. 237/2012 pone anzitutto un obbligo di cooperazione dell’Italia con la CPI, conformemente alle disposizioni dello Statuto di Roma, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (art. 1). La legge individua nel Ministro della giustizia l’organo competente per i rapporti con la Corte, eventualmente d’intesa con gli altri ministri interessati. Il Ministro della giustizia riceve la richieste, vi dà seguito e presenta alla Corte atti e richieste (art. 2). La legge stabilisce inoltre che le richieste formulate dalla Corte penale internazionale siano trasmesse per l’esecuzione al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma.
Giudice competente è la Corte d’appello di Roma.
La normativa regola inoltre la procedura di consegna di una persona oggetto di un mandato di arresto della Corte, nonché l’eventuale applicazione di un provvedimento di custodia cautelare, anche prima che sia intervenuta la richiesta di consegna vera e propria. Sono previste infine le procedure per l’esecuzione delle pene inflitte dalla Corte in Italia.
4.Come anticipato, manca nell’ordinamento italiano la normativa di adattamento al diritto penale internazionale sostanziale: non tutti i crimini di competenza della Corte costituiscono infatti reato ai sensi dalla legislazione italiana.
Molti anni sono trascorsi dalla ratifica del trattato di Roma, e da allora poco o nulla si è fatto. Di recente, i conflitti alle porte dell’Europa hanno riproposto all’attenzione il problema della tutela dei diritti umani e dei crimini internazionali e quindi della indifferibilità di un intervento normativo volto all’adeguamento del nostro ordinamento ai principi in materia previsti dal Trattato di Rom.
Sebbene il legislatore con decreto legge n. 421/2001 convertito in legge n. 6/2002, in attesa di riordinare la materia abbia disposto l’applicazione del titolo “dei reati contro le leggi e gli usi della guerra”, in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, la disciplina vigente appare inadeguata e pecca per eccesso e per difetto: per difetto, in quanto non prevede tutte le fattispecie contenute nello Statuto di Roma, per eccesso, perché prevede alcune fattispecie obsolete ed inapplicabili, nonché con sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie.
Per le dette ragioni era stata salutata con favore l’istituzione, con D.M. 22 marzo 2022, di una Commissione ministeriale presso il Gabinetto della Ministra della giustizia Marta Cartabia, che ha tenuto la sua prima riunione di insediamento il 31 marzo 2022 e altre due riunioni plenarie presso il Ministero l’11 e il 24 maggio 2022.
Questa Commissione ha concluso i lavori il 31 maggio 2022, consegnando un “codice dei crimini internazionali” che recepiva l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, dando al contempo attuazione allo Statuto di Roma.
La caduta del Governo Draghi non ha consentito la prosecuzione di tali lavori, che sono stati poi ripresi dal successivo Governo per portare a termine il lavoro svolto nella precedente legislatura, mediante nomina di un gruppo di lavoro, in data 12 gennaio 2023, il quale due mesi dopo consegnava il codice. Tuttavia nessuna ulteriore notizia è più trapelata in ordine alle sorti del lavoro presentato.
Oggi pertanto persiste l’inerzia e l’inadempienza del nostro Paese nel dare seguito allo Statuto di Roma.
5. Legge 237/2012 . Adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale.
5.1.Le disposizioni generali
Il Capo I della legge 237/2012 (articoli da 1 a 10) contiene le disposizioni generali, individuando le autorità competenti e le modalità di cooperazione con la Corte penale internazionale.
In particolare, l’articolo 1 afferma che la cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale avviene sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto della Corte stessa, nel limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
L’articolo 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale mentre il successivo articolo 3 stabilisce che in materia di consegna, cooperazione ed esecuzione di pene si osservano le norme contenute nel codice di procedura penale (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
L’articolo 4 disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale individuando nella corte d’appello di Roma l’autorità giudiziaria competente.
La trasmissione di atti e documenti è disciplinata dall’articolo 5 che consente al Ministro della giustizia di non procedervi quando ritenga che tali attività possano compromettere la sicurezza nazionale. Non si applica invece l’obbligo del segreto sugli atti d’indagine previsto dall’art. 329 c.p.p.
L’articolo 6 disciplina il caso in cui, in esecuzione di una richiesta di assistenza della Corte penale internazionale, sia necessario citare in Italia una persona che si trova all’estero. La disposizione stabilisce che colui che entra nel nostro territorio non potrà essere sottoposto a qualsivoglia restrizione della libertà personale per fatti antecedenti la notifica della citazione.
L’articolo 7 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale.
L’articolo 8 disciplina l’ipotesi di richieste da parte dell’autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale: la richiesta è formulata per il tramite del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, che si rivolgerà a sua volta al Ministro della giustizia; se il ministro non ottempera entro 30 giorni, il PG presso la corte d’appello può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale.
L’articolo 9 prevede che il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, e il procuratore generale militare presso la corte militare d’appello, assistano – se richiesti – alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto.
L’articolo 10,pur senza risolvere il problema della c.d. doppia incriminazione, ovvero l’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento un catalogo di delitti speculare a quello per il quale ha giurisdizione le Corte penale internazionale, novella il codice penale. La disposizione:
-novella l’art. 322-bis c. p., in tema di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi e funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri, inserendo tra coloro che possono compiere i delitti anche i membri della Corte internazionale di giustizia, i suoi funzionari e i soggetti equiparati. Conseguentemente, si allargano anche i possibili destinatari dell’esborso corruttivo previsto dal secondo comma dell’art. 322-bis;
-introduce nel codice penale l’articolo 343–bis, che estende ai membri della Corte penale internazionale (nonché ai suoi funzionari e soggetti equiparati) l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), con le relative circostanze aggravanti (art. 339), nonché dei delitti di interdizione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340), oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario (art. 342) e oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343);
-novella varie disposizioni del codice penale con l’obiettivo di equiparare al nostro procedimento penale il procedimento che si svolge presso la Corte penale internazionale.
Si tratta, in particolare, delle seguenti novelle al codice penale:
all’art. 368, relativo alla fattispecie di calunnia, per inserire tra le autorità che ricevono le informazioni volte ad incolpare di un reato un innocente ovvero a simulare a carico dell’innocente le tracce di un reato anche la Corte penale internazionale;
all’art. 371-bis, in tema di false informazioni al pubblico ministero, in modo da equiparare al nostro pubblico ministero il procuratore della Corte penale internazionale;
all’art.372, in tema di falsa testimonianza, in modo da prevedere che il delitto possa essere commesso anche da colui che depone dinanzi alla Corte penale internazionale;
all’art. 374, secondo comma, in tema di frode processuale, per consentirne l’applicazione anche in caso di procedimento penale dinanzi alla Corte penale internazionale;
all’art. 374-bis, relativo alla fattispecie di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, per estenderne l’applicazione agli atti destinati ad essere prodotti alla Corte penale internazionale;
all’art. 377, in tema di intralcio alla giustizia, per consentire l’applicazione della fattispecie anche laddove le dichiarazioni debbano essere rese dinanzi alla Corte penale internazionale;
all’art. 378, in tema di favoreggiamento personale, per estendere la fattispecie anche a colui che aiuta taluno a eludere le investigazioni svolte da organi della Corte penale internazionale ovvero a sottrarsi alle ricerche effettuate dagli stessi soggetti;
all’art. 380, primo comma, in merito al delitto di patrocinio o consulenza infedele, per consentirne l’applicazione anche quando l’attività sia svolta dinanzi alla Corte penale internazionale.
5.2.La consegna di persone alla Corte penale internazionale
Il Capo II della legge 237/2012 (articoli da 11 a 14) disciplina la consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano.
In base all’articolo 11, se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla stessa Corte d’appello l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L’interessato dalla misura potrà richiedere, in base allo statuto della Corte, la libertà provvisoria.
L’articolo 12 disciplina la possibile revoca della misura. La custodia cautelare è revocata se:
-dall’inizio dell’esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
-la Corte d’appello si è pronunciata negando la consegna;
-sono trascorsi 20 giorni dal consenso dell’interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna;
-sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale ed essa non è avvenuta.
L’articolo 13 riguarda la procedura per la consegna prevedendo una decisione emessa in camera di consiglio dalla corte d’appello di Roma. Il giudice italiano può negare la consegna solo nelle seguenti ipotesi:
-la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento restrittivo della libertà personale;
-non vi è corrispondenza tra l’identità della persona richiesta e di quella oggetto della procedura di consegna;
-la richiesta della Corte penale internazionale contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
-per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile.
Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la Corte d’appello di Roma dovrà sospendere – salva la manifesta infondatezza – con ordinanza il procedimento, in attesa di una pronuncia della medesima Corte penale.
Sia nell’ipotesi di consenso dell’interessato sia in quella di favorevole pronuncia della corte d’appello di Roma, spetta al Ministro della giustizia – con proprio decreto – provvedere entro 20 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.
L’articolo 14 stabilisce che la misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta provvisoriamente, anche prima che pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna. In tal caso, la custodia sarà revocata se entro 30 giorni la Corte penale internazionale non richiede la consegna.
5.3.L’esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale
Il Capo III della legge 237/2012 (articoli da 15 a 24) disciplina l’esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale.
In primo luogo la legge attribuisce la competenza a conoscere dell’esecuzione del provvedimento della Corte penale internazionale, ai sensi dell’art. 665, comma 1, c.p.p., alla Corte d’appello di Roma, che è dunque giudice dell’esecuzione dei provvedimenti della Corte (articolo 15).
Nel caso in cui l’Italia – a seguito di sentenza definitiva – sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva, in base all’articolo 16 il Ministro della Giustizia deve chiedere alla Corte d’appello il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale.
L’articolo 17 dispone che l’esecuzione della pena avverrà in base all’ordinamento penitenziario italiano (L. n. 354/1975) e in conformità allo statuto e al regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale. Il Ministro della giustizia potrà disporre che il trattamento penitenziario del detenuto avvenga secondo il regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bisdell’ordinamento penitenziario.
Spetta alla Corte penale internazionale il controllo sull’esecuzione carceraria (articolo 18) e il Ministro della giustizia dovrà trasmettere immediatamente alla Corte ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione; se la Corte internazionale ritiene di non consentire l’accesso ad una misura prevista dal nostro ordinamento, il Ministro può chiedere alla Corte di disporre il trasferimento del condannato in altro Stato.
L’articolo 19 disciplina gli ulteriori obblighi di tempestiva informazione alla Corte penale internazionale a carico del Ministro della Giustizia e riferiti alla situazione del condannato (morte, evasione, avvenuta espiazione della pena, nuovi procedimenti penali) mentre l’articolo 20 stabilisce che il luogo di espiazione della pena possa consistere in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare.
L’articolo 21 della legge dispone in ordine all’esecuzione delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale, la Corte d’appello di Roma può provvedere all’esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte penale internazionale; i beni confiscati vengono messi a disposizione della Corte internazionale per il tramite del Ministero della giustizia, che agirà in base a modalità da individuare con decreto. La disposizione disciplina, altresì, l’esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime.
Nel caso di difficoltà nell’esecuzione di provvedimenti sopra indicati, l’articolo 22 disciplina la procedura di consultazione con la Corte penale internazionale, la cui finalità è anche la conservazione dei mezzi di prova.
L’articolo 23 reca una serie di disposizioni in materia di giurisdizione, prevedendo l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella penale militare. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni attribuite al Ministro della giustizia devono essere esercitate d’intesa con il Ministro della difesa, restando salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all’ordinamento penitenziario militare.
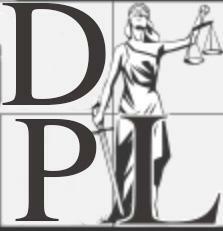
Commenti recenti