Da rileggere: Montesquieu, la tripartizione quale limite al potere
(Fonte: Centro Studi Livatino. 10 Dicembre 2021)
Aldo Rocco Vitale.
Per Montesquieu «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore[…]. Dei tre poteri, dei quali abbiamo parlato, quello giudiziario è in un certo senso nullo».
1. Nato il 18 gennaio 1689 all’interno di una celebre famiglia di giuristi appartenente alla nobiltà di toga aquitana, Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, meglio noto solamente come Montesquieu, studiò in gioventù dai padri oratoriani di Juilly, completando i suoi studi giuridici e divenendo già nel 1714 consigliere del Parlamento di Bordeaux. Studioso di botanica, fisica e anatomia fu presto accolto dall’Accademia delle scienze di Bordeaux, venendo più tardi eletto alla prestigiosa Académie française fondata dal cardinale de Richelieu.
In questo contesto ebbe a intraprendere i suoi viaggi, e la sua fama cominciò ad essere estesa oltre l’ambito provinciale e nazionale, avendo visitato l’Italia, la Germania, l’Austria, l’Inghilterra. Tra le sue opere principali si devono ricordare le “Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza”, le “Lettere persiane”, “Lo spirito delle leggi”, e gli “Scritti postumi”. Il pensiero di Montesquieu, su cui è vastissima la letteratura[1], sebbene non sistematico e non del tutto “originale” in alcune delle sue più note formulazioni, è degno di considerazione poiché può ritenersi come il fondamento del costituzionalismo odierno, nonché la fucina di alcuni dei principi costitutivi dell’odierno Stato di diritto, senza i quali gli Stati e le istituzioni occidentali non potrebbero avere l’attuale forma e l’attuale orizzonte di senso in favore della libertà, della persona e del diritto.
2. Le linee direttrici generali del pensiero di Montesquieu si possono identificare in almeno tre profili principali: il problema del potere; il tema della libertà; la natura del diritto.
Per quanto riguarda il potere occorre tener presente l’epoca storica in cui egli ha eretto il suo edificio teoretico, cioè l’epoca immediatamente successiva a quella dei grandi utopisti come Tommaso Moro, Tommaso Campanella e Francesco Bacone, e a quella dei “grandi inventori” del pensiero assolutistico come Niccolò Macchiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes: per essi, in sintesi, il potere è svincolato da ogni limite etico-giuridico, e anzi il potere sottomette di buon grado e necessariamente la fenomenologia giuridica, di essa servendosi per un verso per auto-legittimarsi, per es. tramite lo strumento del contratto sociale con cui i consociati cedono libertà e diritto in favore del Leviathano, e per altro verso per garantire la propria effettività. Il potere, nell’ottica assolutistica, non concede spazi di manovra che consentano la sua messa in discussione, per cui esso non soltanto deve essere assoluto, ma deve altresì essere indiviso, come massima prerogativa del sovrano, cui spetta il triplice compito di legiferare, di governare e di iuris-dicere.
Se già John Locke aveva reagito al pensiero assolutistico riaffermando la matrice giusnaturalistica del diritto e delle istituzioni politiche ad esso subordinate, tanto da tratteggiare in modo primordiale l’esigenza della condivisione del potere contro la sua concentrazione, idea del resto poi ripresa anche da Immanuel Kant nella sua organizzazione istituzionale dello Stato delineata ne “La metafisica dei costumi”, soltanto Montesquieu cristallizza una compiuta riflessione sul potere e sulla divisione del medesimo per evitare le sue degenerazioni.
3. A tal fine, in primo luogo, riprendendo un antico topos teoretico ascrivibile alla filosofia politico-giuridica di Aristotele, Montesquieu distingue differenti forme di governo ispirate da diversi principi: la democrazia è fondata sulla virtù, il governo aristocratico dalla moderazione (poiché là dove maggiori sono le disuguaglianze, maggiore sarà la necessità della moderazione), il governo monarchico è illuminato dal principio dell’onore, e infine il governo dispotico, che si regge sulla paura di cui il despota si serve per tenere asserviti i sudditi «avviliti al livello di bestie educate a comportarsi bene per timore di ricevere frustate».[2]
In secondo luogo, Montesquieu sancisce il principio per cui soltanto se il potere è controbilanciato dal potere stesso si può evitare che esso degeneri[3]: occorre che esso non sia concentrato nelle mani del sovrano, ma scorporato secondo le differenti funzioni del legiferare, del governare e del rendere giustizia. Con la condivisione del potere, cioè smembrandolo nelle sue tre applicazioni, si può effettivamente garantire la libertà politica e giuridica, poiché ciascun potere sarà controllato e frenato dagli altri due, evitando la sua assolutizzazione e i mali che da ciò discendono per i cittadini e per lo Stato stesso.
In questa prospettiva, perno centrale del principio di separazione dei poteri, sono la legge e il principio di legalità come espressioni del freno dell’arbitrio del potere. Come è stato osservato, infatti, «la separazione dei poteri sorge e opera per garantire l’applicazione pratica del principio di legalità. Ne deriva che non può concepirsi separazione dei poteri nello Stato dispotico che si caratterizza proprio per la mancanza di leggi generali».[4]
4. La legge, però, non è la semplice espressione del comando del sovrano, ma è qualcosa di diverso, qualcosa di più, cioè la manifestazione della natura razionale dell’essere umano[5], in quanto se Montesquieu rifiuta «ogni soluzione fatalistica non per questo il suo metodo cade nell’empirismo. Si fa della legge un’idea molto alta: essa è – o dovrebbe essere – l’incarnazione della ragione»[6]. Il principio di legalità su cui Montesquieu fonda la sua teoria di separazione dei poteri, dunque, traduce il principio di razionalità del diritto, facendo convergere entrambi verso l’orizzonte della libertà che dovrebbe informare uno Stato autenticamente giuridico.
Per Montesquieu «lo Stato dispotico si differenzia da ogni altra forma perché in esso non vige il principio di legalità. Lo Stato dispotico è quello in cui il principe è tutt’uno con lo Stato e le leggi; il principio deve essere la paura poiché non esistono leggi che possono governare i sudditi senza l’applicazione continua di una forza irresistibile. Si tratta quindi di un ordinamento il cui solo principio razionale è l’applicazione irrazionale della forza. Non esistono leggi come norme generali, prefissate e oggettivamente vigenti; tutto è affidato al capriccio momentaneo del principe. Il dispotismo è dunque il regno dell’arbitrio[…]. Per Montesquieu l’arbitrio nasce dove non esiste la generalità della legge».[7]
Il giurista francese scrive in modo espresso che «negli Stati dispotici il governo per la natura sua, reclama una obbedienza estrema[…].E’ impossibile proporre temperamenti, modifiche, accomodamenti, rinvii, controproposte, discussioni, rimostranze, cose eguali o migliori. L’uomo è una creatura che obbedisce ad una creatura che vuole[…]. Agli uomini come agli animali non rimane che l’istinto, l’obbedienza e il castigo».[8]
5. La tripartizione del potere, precisa il filosofo, deve essere intesa nel senso che il potere reale è quello che deve essere diviso tra il legislativo e l’esecutivo, poiché il giudiziario è, dei tre, quello che maggiormente deve essere tenuto a freno sia per garantire la effettiva libertà degli altri distinti poteri, sia per la natura stessa del potere giudiziario, facendo «della separazione dei poteri un sistema di controllo e di equilibrio legale tra le parti di una costituzione»[9].
Montesquieu precisa sul punto, infatti, che «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore[…]. Dei tre poteri, dei quali abbiamo parlato, quello giudiziario è in un certo senso nullo»[10]. In questa specifica prospettiva si sviluppa il cosiddetto “garantismo penale”[11], per cui l’imputato deve essere giudicato da suoi pari[12], va garantita la presunzione d’innocenza come presidio generale della libertà per tutta la comunità politica e giuridica[13], e una condanna deve essere sorretta in modo inequivocabile da una prova che superi ogni ragionevole dubbio in virtù dell’applicazione del principio unus testis, nullus testis[14].
La limitazione del potere e l’equilibrio nella condivisione del potere, dunque, costituiscono i presupposti per la creazione di un sistema politico e giuridico che sia realmente garante della libertà politica. La libertà, tuttavia, non significa assenza di limiti per il cittadino e liceità dell’arbitrio e del capriccio. Come il potere è garantito dall’equilibrio con un altro potere, così anche l’agire sociale del cittadino non può che essere garantito dalla legge, tanto da ritenere che l’autentica libertà è soltanto quella che si può esperire all’interno della cornice giuridica[15]. In questa direzione Guido Fassò ha sottolineato come «è ripreso qui il motivo lockiano secondo il quale la legge, anziché limitarla, assicura la libertà del cittadino: che è il principio del costituzionalismo moderno e dello Stato di diritto»[16].
6. L’intero edificio teorico del pensiero del filosofo francese si regge su una particolare concezione del diritto, cioè quella sostanzialmente giusnaturalistica, alla luce della quale il diritto non può ridursi alla mera forma della norma come contenitore della volontà legislativa, poiché esistono anche leggi anteriori e superiori rispetto a quelle positive[17]. Lo stesso Montesquieu ha insegnato, ricordando ai posteri l’antica sapienza dei nobili padri della civiltà del diritto inevitabile al fine di garantire la libertà contro la schiavitù e lo Stato di diritto contro la deriva dispotica[18], che «prima di tutte queste leggi vi sono quelle di natura, così chiamate perché derivano unicamente dalla costituzione dell’essere nostro»[19].
[1] Ex plurimis cfr.: Jean Starobinski, Montesquieu, Einaudi, Torino, 2002; Louis Althusser, Montesquieu. La politica e la storia, Manifestolibri, Roma, 2008; Antonio Cucciniello, Il potere che limita il potere. Un’analisi del costituzionalismo di Montesquieu, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007; Mario Cattaneo, Il liberalismo penale di Montesquieu, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; Jean-Baptiste d’ Alembert, Elogio di Montesquieu, Liguori, Napoli, 2010; Antonio Merlino, Interpretazioni di Montesquieu, Il Formichiere, Foligno, 2018.
[2] Jean-Jeacques Chevallier, Storia del pensiero politico, Il Mulino, Bologna, 1981, Vol. II, pag. 316.
[3] «Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere»: Charles de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, a cura di Sergio Cotta, Utet, Torino, 2005, Vol. 1, pag. 274.
[4] Gaetano Silvestri, La separazione dei poteri, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 289.
[5] «La legge è la ragione umana in quanto governa tutti i popoli della terra»: Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 63.
[6] Jean Touchard, Storia del pensiero politico, Etas, Milano, 2000, pag. 317.
[7] Gaetano Silvestri, op. cit., pag. 283.
[8] Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 95.
[9] George Sabine, Storia delle dottrine politiche, Etas, Milano, 1967, pag. 428.
[10] Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 276-282.
[11] «Un monarca, quando perdona i suoi sudditi, immagina sempre di fare un atto di clemenza, mentre spessissimo compie un atto di giustizia. Crede, al contrario, di fare un atto di giustizia quando punisce, ma spesso compie un atto di tirannia»: Charles de Montesquieu, Scritti postumi, Bompiani, Milano, 2017, pag. 1529.
[12] «Bisogna poi che i giudici siano della stessa condizione dell’accusato, o suoi pari, perché egli non possa sospettare di esser caduto nelle mani di persone inclini ad usargli violenza»: Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 279.
[13] «Quando l’innocenza dei cittadini non è garantita non lo è neppure la libertà»: Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 322.
[14] «Le leggi che fanno perire un uomo sulla base della testimonianza di una sola persona sono fatali per la libertà. La ragione esige almeno due testimoni, perché un testimone che afferma e un accusato che nega sono in parità, e ci vuole un terzo per risolvere la questione»: Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 323.
[15] «La libertà politica non consiste affatto nel fare ciò che si vuole[…]. La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono e se un cittadino potesse fare ciò che esse proibiscono non sarebbe più libero poiché tutti gli altri avrebbero anch’essi questo stesso potere»: Charles de Montesquieu, op. cit., pag. 273.
[16] Guido Fassò, Storia della filosofia del diritto, Il Mulino, Bologna, 1968, Vol. II, pag. 295.
[17] «Le leggi anteriori alle leggi positive non sono, evidentemente, leggi causali, ma leggi-comando, che non hanno origine nella volontà di legislatori particolari, ma sono consustanziali alla natura o alla ragione umana»: Raymond Aron, Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano, 2008, pag. 64.
[18] «La legge naturale consiste in quei diritti e doveri di individui e nazioni che dovrebbero essere rispettati ovunque a causa del bene che producono»: Leo Strauss – Josepg Cropsey, Storia della filosofia politica, Il Melangolo, Genova, 1995, pag. 314.
[19] Charles de Montesquieu, op., cit., pag. 59.
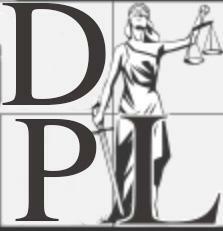
Commenti recenti