La riforma costituzionale tedesca del ‘freno all’indebitamento’: un primo sguardo
(Fonte. Senato della Repubblica. Legislatura 19ª – Dossier n. 77[1])
1.Introduzione. Pochi giorni prima della sessione costitutiva del nuovo Bundestag risultante dalle elezioni del 23 febbraio 2025, tenutasi il succesivo 25 marzo, nella seduta straordinaria del 18 marzo il 20° Bundestag ha approvato il disegno di legge n. 20/15096 di revisione costituzionale proposto da SPD e CDU/CSU[2]. Tale disegno di legge ha ad oggetto la modifica del c.d. “freno all’indebitamento” (Schuldenbremse)[3]: il provvedimento, a tale scopo, reca modifiche agli articoli 109 e 115 della Legge Fondamentale (Grundgesetz, GG), ed introduce il nuovo articolo 143h.
Con 512 voti favorevoli, 206 voti contrari e nessun astenuto, il Bundestag ha dunque approvato il d.d.l. in questione. Successivamente, nella seduta plenaria del 21 marzo, il Bundesrat ha a sua volta approvato il provvedimento, con una maggioranza superiore ai due terzi (53 voti a favore e nessun voto contrario, sebbene quattro Länder si siano astenuti: Brandeburgo, Renania-Palatinato, Sassonia-Anhalt e Turingia)[4].
Essendo stata approvata tanto dal Bundestag quanto dal Bundesrat con una maggioranza pari o superiore alla soglia dei due terzi, la legge di revisione costituzionale sarà ora firmata e promulgata dal presidente federale della Germania, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla promulgazione.
Definito dalla stampa come Schuldenpaket (pacchetto del debito, ndr), il provvedimento introduce una riforma i cui profili fondamentali sono:
-l’esenzione dalla regola del debito con riferimento alle spese per la difesa e a determinate spese per le politiche di sicurezza superiori ad un determinato importo (1% del PIL nominale);
-l’istituzione di un fondo speciale da 500 miliardi di euro per l’ammodernamento infrastrutturale del paese (reti elettriche, ospedali, strade, ferrovie) e per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2045;
-l’allentamento della regola sul debito con riferimento ai Länder, mediante estensione al livello regionale dell’opzione d’indebitamento di carattere strutturale già prevista per il Bund (il principio del pareggio di bilancio deve considerarsi comunque rispettato in caso di indebitamento complessivo compreso entro lo 0,35% del PIL nominale).
Come si apprende dalla relazione illustrativa della proposta di legge (stampato 20/15096), l’esigenza di predisporre tale intervento di revisione costituzionale si identifica, anzitutto, nelle tensioni geopolitiche e geoeconomiche che, secondo i partiti promotori della riforma, continuerebbero a profilarsi a causa del persistere della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Il conflitto in corso avrebbe, infatti, radicalmente mutato la situazione della sicurezza in Europa. A tal proposito, si legge nella relazione, l’insediamento della neoeletta amministrazione statunitense, con il proprio programma di graduale disimpegno nella politica di sicurezza europea e di riorganizzazione della politica di sostegno all’Ucraina, esporrebbe la Germania e gli altri Stati membri dell’Unione europea alla circostanza di dover sostenere, nel prossimo futuro, maggiori oneri finanziari in materia di sicurezza, allo scopo di rafforzare le proprie capacità di difesa, tanto nella dimensione nazionale quanto nella dimensione europea.
Con più specifico riguardo al profilo della riforma riguardante il fondo speciale per le infrastrutture, l’esigenza si identificherebbe altresì nella fase di stagnazione che l’economia tedesca vive da oltre due anni, inidonea a garantire la disponibilità di una rete infrastrutturale sviluppata, funzionale e moderna, e in ogni caso adeguata a supportare il suddetto incremento del potenziale di difesa nazionale.
Proprio alla luce delle crisi degli ultimi anni, e in vista delle numerose nuove sfide, la relazione evidenzia come l’intervento sia necessario a supportare, altresì, le grandi esigenze di finanziamento dei Länder e dei comuni, funzionali, ad esempio alla configurazione di un sistema educativo moderno, alla digitalizzazione dell’amministrazione, all’integrazione dei rifugiati e al rafforzamento della protezione civile.
Sullo sfondo della riforma, tuttavia, si intravede la crisi di bilancio provocata dalla sentenza del Tribunale costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) del 15 novembre 2023. In sintesi, con la suddetta pronuncia il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che il trasferimento dell’autorizzazione all’indebitamento per l’emergenza pandemica ad un diverso fondo, preordinato alla transizione energetica e climatica (Energie-und Klimafonds – EKF) violasse il “freno all’indebitamento” sancito nei richiamati articoli 109, comma 3, e 115, comma 2, della Legge Fondamentale. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato la violazione del principio di annualità del bilancio (articolo 110, comma 2), sottolineando che non sia consentito approvare integrazioni al bilancio a esercizio finanziario già iniziato, né estendere autorizzazioni all’indebitamento oltre l’anno fiscale di riferimento. In conseguenza della pronuncia, l’esecutivo è stato costretto a reperire in altro modo le risorse precedentemente coperte dai prestiti autorizzati con la legge dichiarata nulla[5].
2.Le disposizioni dello Schuldenpaket
Il provvedimento, approvato dal Bundestag in prima lettura con emendamenti e, successivamente, approvato in via definitiva dal Bundesrat, reca le seguenti modifiche alla Legge Fondamentale.
I novellati articoli 109, paragrafo 3 e 115, paragrafo 2 della Legge Fondamentale stabiliscono che le spese per la difesa, nonché determinate spese per la politica di sicurezza, eccedenti l’1% del prodotto interno lordo nominale saranno esenti dalla regola del freno al debito, che attualmente limita allo 0,35% del PIL nominale la quota di deficit consentita al solo Bund.
Nello specifico, si prevede che debba essere dedotto dal reddito derivante dai prestiti da prendere in considerazione l’importo per il quale le seguenti categorie di spesa superano l’1% del prodotto interno lordo nominale:
-le spese per la difesa;
-le spese federali per la protezione civile e per i servizi di intelligence;
-le spese per la protezione dei sistemi informatici e l’assistenza agli Stati aggrediti in violazione del diritto internazionale.
Merita evidenziare che nella bozza originaria del disegno di legge di revisione costituzionale si prevedeva l’esclusione dalla regola del debito unicamente per le spese per la difesa. Con i successivi passaggi parlamentari (in particolare, a seguito della discussione e dell’approvazione del testo in Commissione Bilancio, in data 16 marzo, stampato 20/15117), sono state apportate talune modifiche al testo, sulla base di una proposta di emendamento congiunta dei gruppi parlamentari SPD, CDU/CSU e Alleanza 90/Verdi: tali modifiche hanno, appunto, esteso l’esenzione alle richiamate tipologie di spesa per le politiche di sicurezza.
Le modifiche apportate dalla riforma all’articolo 109, paragrafo 3, inoltre, introducono un’ulteriore opzione di indebitamento a beneficio dei Länder, di carattere strutturale, che si aggiunge alla componente ciclica del debito e all’opzione del ricorso al deficit in situazioni di emergenza, già previsti dalle vigenti disposizioni costituzionali[6]. La novellata disposizione stabilisce che l’indebitamento dei Länder soddisfi in ogni caso il principio del pareggio di bilancio (sancito dal paragrafo 1, frase 1, del vigente articolo 109 GG), a condizione che, nel suo complesso, non superi lo 0,35% del prodotto interno lordo nominale. In tal modo, la novella estende ai Länder il regime già previsto, secondo il vigente disposto dell’articolo 109, paragrafo 3, esclusivamente in favore del Bund.
La medesima disposizione, in seguito alla novella, stabilisce che la distribuzione tra i singoli Länder del volume del debito autorizzato per il loro insieme sia effettuata da una legge federale, soggetta all’approvazione del Bundesrat, subordinando all’entrata in vigore di quest’ultima la legittimazione dei Länder ad utilizzare tale margine di indebitamento strutturale.
Aggiunge la novellata disposizione che le norme di leggi statali esistenti, le quali non rispettino il suddetto limite alle entrate da prestiti, cessino di essere applicate. In questo modo, secondo la relazione illustrativa, si intende consentire l’applicazione immediata e diretta dei nuovi massimali di credito, modificati dalla riforma, in tutti gli Stati federati.
Il nuovo articolo 143h, introdotto dal provvedimento in esame nella Legge Fondamentale, autorizza il Governo federale ad istituire un Fondo speciale finalizzato a soddisfare le esigenze di investimento del Governo federale, dei Länder e delle autorità locali nel settore delle infrastrutture.
Nella relazione illustrativa della proposta di legge (stampato 20/15096), si legge che l’istituzione di tale fondo garantisce una base di finanziamento a lungo termine per gli investimenti del governo federale per l’ammodernamento infrastrutturale della Germania.
Il fondo speciale potrà essere dotato di autorizzazioni di credito fino a un totale di 500 miliardi di euro, per le quali si esclude l’applicazione della regola del freno al debito di cui all’articolo 109, paragrafo 3, e all’articolo 115, paragrafo 2, della Legge Fondamentale[7]. Il nuovo articolo, in proposito, prevede anche il criterio dell’addizionalità per gli investimenti, stabilendo, in particolare, che l’addizionalità sussiste qualora nel bilancio federale sia raggiunta una quota di investimenti adeguata con riferimento al rispettivo esercizio finanziario. La durata dell’autorizzazione agli investimenti del fondo speciale è limitata a dodici anni. La disposizione prevede che i dettagli del suddetto fondo siano disciplinati da legge federale.
Dalla complessiva dotazione del fondo speciale, la disposizione prescrive che:
-100 miliardi di euro confluiscano nel Fondo per il clima e la trasformazione, il cui utilizzo sarà funzionale al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2045;
-100 miliardi di euro siano messi a disposizione dei Länder per investimenti nelle relative infrastrutture. Al riguardo, la norma specifica che i Länder riferiscano al Bund in merito al relativo utilizzo e che il Bund medesimo sia autorizzato a verificarne l’impiego appropriato. La normativa di dettaglio viene delegata al legislatore federale, con l’approvazione del Bundesrat.
3.Considerazioni conclusive
Nel complesso, la riforma – approvata al Bundestag con i voti di CDU/CSU, SPD e Verdi ed osteggiata da liberali, AfD, Linke e dal partito di Sahra Wagenknecht (BSW) – definisce un vasto piano di stimolo e di rilancio dell’economia tedesca, valutato in oltre mille miliardi di euro.
Gli investimenti a vantaggio della Bundeswehr delineano un cambiamento di paradigma nella politica di difesa tedesca ed europea. Un cambiamento – come sottolineato nella discussione parlamentare dal leader del gruppo CDU/CSU, nonché Cancelliere in pectore Friedrich Merz – reso necessario dalla situazione internazionale e da quella della sicurezza in Europa, a partire dal presupposto che la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina non si possa considerare solo contro l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche contro l’intera Europa.
Il Cancelliere in pectore ha affermato che “L’Europa non può ancora difendersi da sola, ma solo insieme agli Stati Uniti”, precisando poi che “deve invece procedere passo dopo passo verso una difesa europea indipendente e una comunità di difesa europea”. “La decisione odierna – ha poi aggiunto– è anche il primo passo verso una comunità della difesa europea, alla quale anche Paesi non appartenenti all’Ue potranno aderire”.
In merito al fondo speciale, il Cancelliere in pectore Merz ha rilevato come esso sarà funzionale alla necessità di rinnovo di talune infrastrutture pubbliche, precisando che la relativa istituzione non inficia la necessità di consolidamento dei bilanci pubblici.
[1] Dossier a cura di Luca Coppola, nell’ambito di un tirocinio formative presso il Servizio Studi del Senato della Repubblica.
[2]In Germania non è la prima volta che il Bundestag sciolto torna a riunirsi in plenaria dopo le elezioni. Precedenti si sono avuti nel 1976 (due sedute), nel 1998 (una seduta) e nel 2005 (una seduta). Tali precedenti, tuttavia, non hanno mai avuto a oggetto una revisione costituzionale e, peraltro, nel caso delle due sedute del 1976 non era ancora entrato in vigore l’attuale art. 39, comma 2, della Legge Fondamentale, in forza del quale “Il Bundestag si riunisce non oltre il trentesimo giorno dalla sua elezione”.
[3] Il nucleo essenziale di tale regime, introdotto dalla riforma costituzionale del 2009 (Föderalismusreform II) , è contenuto nel vigente articolo 109, paragrafo 1, frase 1 della legge Fondamentale, ai sensi del quale i bilanci del Bund e dei Länder devono rispettare il requisito del pareggio di bilancio senza ricorso a prestiti. Il vigente paragrafo 3 della medesima disposizione, peraltro, prevede un’asimmetria nella disciplina fiscale, e del ricorso al deficit, relativa ai due livelli di governo, federale e statale, attribuendo esclusivamente al Bund un margine di manovra, seppur ristretto, entro il principio del pareggio: stabilisce infatti che tale principio debba considerarsi rispettato se le entrate dai prestiti non superino lo 0,35 del PIL nominale (c.d. componente strutturale del debito). La maggiore rigidità della disciplina fiscale nei confronti dei Länder era, tuttavia, originariamente compensata dal disposto dell’articolo 143d, paragrafo 1, della Legge Fondamentale, che autorizzava i Länder a derogare al nuovo regime fino al 31 dicembre 2019 (mentre, per quanto riguarda il Bund, il freno all’indebitamento sarebbe divenuto efficace a partire dall’esercizio del 2016). Per un approfondimento, si rinvia al relativo Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica,La riforma costituzionale tedesca del 200La riforma costituzionale tedesca del 2009 (Föderalismusreform II) e il freno all’indebitamento. La riforma costituzionale in esame interviene anche sui descritti profili della vigente disciplina fiscale.
[4]Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2 della Legge Fondamentale, in Germania l’approvazione di una legge costituzionale è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei due terzi tanto al Bundestag quanto al Bundesrat.
[5]Si ricorda, ad esempio, che la prima iniziativa è stata l’approvazione nel mese di dicembre 2023 di una legge integrativa del bilancio per legittimare i prestiti per il Energie- und Klimafonds già accesi nel medesimo anno finanziario, utilizzando ancora la dichiarazione d’emergenza prevista dall’articolo 115, comma 2. Il Governo ha motivato l’emergenza con la necessità di effettuare interventi urgenti per riparare le conseguenze negative delle alluvioni in Westfalia e Renania e della guerra russo-ucraina.
[6] Il vigente articolo 109, paragrafo 1, prevede infatti che il Bund e i Länder possano derogare al requisito del pareggio di bilancio, introducendo norme speciali a ciò dirette, alternativamente: a fronte di congiunture economiche che si discostino dalla normalità, al fine di tener conto in modo simmetrico dei loro effetti sul bilancio sia nelle fasi di crescita sia nelle fasi di recessione; in caso di calamità naturali o situazioni di emergenza che sfuggano al controllo dello Stato e incidano in modo significativo sulla situazione finanziaria dello stesso. La stessa disposizione aggiunge che ai fini dell’esenzione dal suddetto vincolo debba essere previsto un adeguato regime di rimborso.
[7]La relazione illustrativa specifica che, nell’ambito delle infrastrutture, le risorse del fondo possono essere utilizzate per finanziare, in particolare, gli investimenti di cui agli articoli 10, paragrafo 3, n. 2, frase 2 della Legge sui principi di bilancio. Si tratta di investimenti nei seguenti settori: protezione civile, infrastrutture di trasporto, strutture ospedaliere, infrastrutture energetiche, infrastrutture per l’istruzione, strutture assistenziali, strutture deputate all’attività scientifica, nonché ricerca, sviluppo e digitalizzazione.
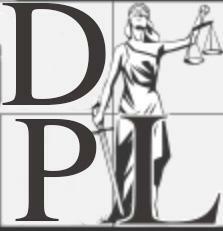
Commenti recenti