Nota redazionale
Secondo alcuni deputati democratici statunitensi, come si legge in alcuni media USA, l’altalena dei dazi e la loro improvvisa sospensione per 90 giorni sarebbero parte di un preciso disegno: far crollare i titoli, acquistarli a basso prezzo e poi cavalcare l’improvvisa risalita per incassare. Un’operazione di insider trading.
Ma cos’è l’insider trading ?
1.Viene definita Insider Trading la compravendita di strumenti finanziari da parte un insider, cioè di una persona che, in virtù della posizione che ricopre, è a conoscenza di informazioni privilegiate che vengono appunto utilizzate per ottenere un profitto.
Le informazioni sono privilegiate se sono specifiche e di contenuto determinato, non sono a disposizione del pubblico, sono concernenti strumenti finanziari e sono idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari cui si riferiscono
2.Quanto all’ordinamento italiano, Il delitto di insider trading è stato disciplinato con la L. 17 maggio 1991, n. 157, in attuazione della direttiva 89/592/CEE che introduceva il concetto di informazione privilegiata. La disposizione, che puniva anche il c.d. insider secondario, era imperniata sull’obbligo assoluto di astensione dall’operare o dal comunicare a terzi informazioni riservate di cui si entrava in possesso. Nel 1998, con la legge n. 58 del 1998, Testo unico della Finanza (TUF), il reato di insider trading è stato trasposto nell’art. 180 del TUF e rubricato “abuso di informazioni privilegiate”. La configurazione attuale dell’illecito penale deriva invece dalla L.8 aprile 2005, n. 62, in attuazione delle direttive UE n. 6 (MAD I) e n. 124 del 2003. In particolare, la riforma del 2005 ha modificato la struttura del delitto pur mantenendo invariata la rubrica e lo ha trasferito all’art. 184 TUF[1].
Il delitto di abuso di informazioni privilegiate punisce il soggetto che, essendo in possesso di un’informazione privilegiata in ragione della carica ricoperta nell’emittente o per l’esercizio di un’attività lavorativa, professione o funzione, anche pubblica, o di un ufficio, pone in essere condotte di trading, tipping e tuyautage. L’illecito è quindi incentrato sul divieto di uso e comunicazione a terzi di un’informazione acquisita in ragione di una carica o dell’attività lavorativa svolta (c.d. nesso funzionale), che viene definita come privilegiata. Tale informazione, quale elemento di fattispecie, trovava la sua definizione all’epoca dei fatti della presente pronuncia (risalenti al 2008), prima della riforma europea e di quella ad opera del d.lgs. n. 107 del 2018, all’art. 181 TUF.
Infatti, a distanza di oltre dieci anni dalla prima direttiva europea, al fine di rendere più effettiva ed omogenea la repressione dei fenomeni illeciti in tutto il territorio dell’UE, la materia del market abuse è stata oggetto nel 2014 di un intervento riformatore. L’UnioneeEuropea ha adottato il Regolamento n. 596 del 2014 (MAR), concernente la modifica alla disciplina amministrativa degli abusi di mercato -che contiene all’art. 7 la nuova definizione di informazione privilegiata- e la direttiva 2014/57/UE (MAD II) inerente la riforma degli illeciti penali. Questi hanno abrogato le precedenti direttive (la n. 6 e la n. 124 del 2003).
Secondo i citati provvedimenti, la legge di delegazione europea 2014 (L. n. 114/2015) indicava al Governo di dare attuazione alle riforme e quindi di adeguare la normativa interna in materia di market abuse. Il Governo ha invece ritenuto l’Italia già conforme alla nuova disciplina degli abusi di mercato e, pertanto, non ha dato attuazione alla direttiva MAD II.
Pertanto, alla scadenza del termine per l’attuazione della citata direttiva UE (3 luglio 2016) è entrato in vigore solo il Regolamento MAR perché direttamente applicabile, e che però doveva essere coordinato con le previgenti disposizioni del TUF. Il Governo, con il D.Lgs. n. 107/2018 ha adeguato la normativa interna al solo regolamento MAR, e quindi alla sola disciplina amministrativa degli abusi di mercato. Tuttavia, il legislatore ha modificato la nozione di informazione privilegiata andando ad incidere anche sulla disciplina penalistica. Infatti, è stato abrogato l’art. 181 TUF, che conteneva la definizione di informazione privilegiata e questa è stata inserita all’art. 180, lettera b-ter), TUF tramite un rimando diretto all’art. 7 MAR.
L’art. 181 TUF conteneva una definizione “a cascata” interamente ricalata su quella europea derivante dalla lettura in combinato disposto delle direttive 6 e 124 del 2003.
Al comma 1 il legislatore italiano ha definito in via generale il concetto di informazione privilegiata, mentre ai commi successivi ha specificato il significato di alcuni elementi chiave. L’informazione era considerata privilegiata quando aveva carattere preciso, non era stata resa pubblica, concerneva direttamente o indirettamente uno o più strumenti finanziari, e che se fosse stata resa pubblica avrebbe potuto influire sul prezzo degli stessi. Al comma 3 si definiva il concetto di precisione. Si leggeva nel testo che un’informazione è “precisa” se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Il comma 4 esplicitava uno dei requisiti fondamentali dell’informazione privilegiata: la price sensitivity. Per informazione “price sensitive” (corrispondente grossomodo al concetto di materiality di matrice USA) si intendeva l’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole (reasonable man) avrebbe usato per fondare le proprie ragioni di investimento. Secondo la dottrina, l’investitore ragionevole è un individuo dotato di medie competenze nel mercato in cui l’insider opera.
Come anticipato, il D.Lgs. n. 107/2018 ha abrogato l’art. 181 TUF e contestualmente modificato l’art. 180 TUF con l’inserimento della lettera b-ter), che contiene l’attuale definizione di informazione privilegiata mediante un rimando all’art. 7 MAR. Il legislatore italiano, dunque ha preferito non definire direttamente l’informazione privilegiata, utilizzando la tecnica del rinvio. Pertanto, la definizione di informazione privilegiata è contenuta solo nell’art. 7 del regolamento UE n. 596 del 2014.
La definizione contenuta nel MAR appare quasi totalmente conforme alle direttive abrogate e all’art. 181 TUF. Le novità sono: a) la rilevanza delle informazioni relative a quote d’emissione o ai prodotti oggetto d’asta e correlati (comma 1, lettera c)); b) l’ipotesi della trasmissione dell’informazione dal cliente alla persona incaricata dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari (comma 1, lettera d)); c) l’esplicita inclusione, delle tappe intermedie dei processi prolungati quali informazione privilegiata (comma 3).
La definizione di un elemento di fattispecie del reato di insider trading è contenuta pertanto in una fonte extrastatale, che va a integrare il delitto ex art. 184 TUF, e ciò desta in alcuni esperti perplessità sulla compatibilità di tale tecnica normativa con il principio della riserva di legge[2].
3.L’abuso di informazioni privilegiate costituisce un reato nell’ordinamento italiano ed europeo. I riferimenti normativi principali sono, come anticipato, il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria-TUF e il Regolamento Europeo n. 596/2014 sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) con successive integrazioni e modifiche. L’articolo 184 del TUF prevede in generale per l’abuso di informazioni privilegiate la reclusione da 2 a 12 anni e con una multa variabile da € 20.000 a € 3.000.000.
La CONSOB è il soggetto cui spetta il controllo sui market abuse in Italia.
[1] Si v. D.Federici, “Insider di sé stesso e abuso di informazioni privilegiate: la Corte di cassazione conferma la punibilità anche del creatore della notizia”, in sistemapenale.it, 13 Ottobre 2021
[2] Cfr. M. Gambardella, “Condotte economiche e responsabilità penale”,Giappichelli, 2020, p. 382; L. Picotti, “Sui “tre volti” del diritto penale comunitario, in I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della giornata di studi per Alessandro Bernardi”, a cura di Grandi, Pacini Giuridica, 2021, p. 111; entrambi citati da D.Federici, op. cit.
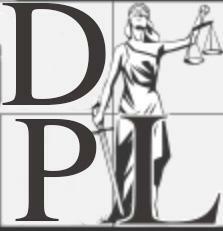
Commenti recenti