(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2618
Nota di Giovanni Patrizi
La ricostruzione del contesto normativo riguardante le prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla protezione sociale della famiglia consente di apprezzare come la giurisprudenza costituzionale abbia affermato, fin dagli anni ottanta, l’operatività della garanzia costituzionale (ex art. 31 Cost.) anche in situazioni indipendenti dall’evento della maternità naturale, riferibili anche alla paternità, sul presupposto che la tutela assolve anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino (e che vanno soddisfatte anche nel caso dell’affidamento, garantendo una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed educazione della prole, senza distinzione o separazione dei ruoli fra uomo e donna: Corte cost. n. 1/1987; n. 179/1993).
L’evoluzione del quadro normativo ha portato, in base alla delega contenuta nella L. 8 marzo 2000, n. 53, all’ introduzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
La L. n. 53/2000, art. 1, lett. a), prevede l’istituzione dei congedi dei genitori in relazione alla generale finalità di promuovere il sostegno della maternità e della paternità. Il D.Igs. n. 151/2001, art. 32, introduce i congedi parentali e dispone che per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro.
Tale diritto compete: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (comma 1, lett. a); al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (comma 1, lett. b).
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (comma 4); ai fini dell’esercizio del diritto il genitore è tenuto, salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo modalità e criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni (comma 3). Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, è dovuta un’indennità, calcolata in misura percentuale sulla retribuzione secondo le modalità previste per il congedo di maternità (art. 34, commi 1 e 4).
Alla luce della disciplina suddetta, il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. Tale diritto, in particolare, viene esercitato, con l’onere del preavviso, sia nei confronti del datore di lavoro, nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, con la conseguente sospensione della prestazione del dipendente, sia nei confronti dell’ente previdenziale, nell’ambito del rapporto assistenziale che si costituisce ex lege per il periodo di congedo, con il conseguente obbligo del medesimo ente di corrispondere l’indennità.
All’inserimento di tale diritto nel campo dei poteri diretti a creare, modificare, estinguere situazioni giuridiche con una manifestazione unilaterale di volontà, senza la partecipazione di colui che deve subirne gli effetti, non sembra ostare il fatto che la legge richieda nel momento genetico della concessione del beneficio il rispetto di taluni oneri formali (cfr. Cass. n. 15973/2017; Cass. n. 2803/ 2015, secondo cui l’esercizio del diritto potestativo al permesso può essere sottoposto ad un procedimento necessario alla verifica, anche da parte del soggetto passivo, degli elementi costitutivi).
In ogni caso la configurazione legale di tale diritto potestativo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori consentiti dall’ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore negli ambiti suddetti (quello del rapporto negoziale e quello del rapporto assistenziale).
Tale verifica, come afferma Cass. n. 16207/2008, trova giustificazione, sul piano sistematico, nella considerazione che anche la titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e arbitrio nell’esercizio di esso e non esclude la sindacabilità e il controllo degli atti, mediante i quali la prerogativa viene esercitata, da parte del giudice. Si configura dunque una corrispondenza oggettiva fra il potere di autonomia conferito al soggetto e l’atto di esercizio di quel potere, secondo un legame ben evidente nella cd. autonomia funzionale i cui poteri sono positivamente esercitati in funzione della cura di interessi determinati, come avviene normalmente nell’autonomia pubblica, ma come avviene anche, sempre più diffusamente, nell’autonomia privata. Anche in questo ambito l’esercizio del diritto soggettivo non si ricollega più all’ attuazione di un potere assoluto e senza limiti ma laddove l’autonomia è comunque collegata alla cura di interessi (soprattutto se interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza) il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abusivo in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2618
Ove si accerti che il periodo di congedo parentale viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.
“ […] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Fatto
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di M.G. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 13 novembre 2020 da (OMISSIS) s.p.a. sulla base di contestazione che addebitava al dipendente di avere, durante il periodo di congedo parentale retribuito ex art. 32 d. lgs. n 151/2001, svolto attività lavorativa di compravendita di autovetture, in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo; la società aveva inoltre contestato la violazione dell’art. 43 c.c.n.l. relativa all’obbligo di comunicazione alla società dello svolgimento di altra attività professionale.
2. La Corte di merito, in dichiarata condivisione della valutazione del giudice di prime cure, ha ritenuto provata la condotta oggetto di addebito emersa all’esito di verifica effettuata dall’agenzia investigativa incaricata dalla società datrice; ha evidenziato che la agenzia in questione era titolare della relativa licenza prefettizia e che in osservanza dell’art. 5 del decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010 aveva ritualmente comunicato alla Prefettura il nome del collaboratore del quale si avvaleva per le investigazioni, che era colui che nello specifico aveva materialmente svolto l’attività di indagine; tanto risultava dalla documentazione prodotta dalla società rispetto alla quale era da escludere la eccepita tardività del relativo deposito la cui necessità era scaturita dalla eccezione, formulata per la prima volta dalla difesa del M.G. solo nel corso dell’udienza di primo grado. Il giudice di appello ha ulteriormente osservato che, in ogni caso, l’acquisizione di tale documentazione, necessaria per l’accertamento della verità di fatti rilevanti al fine della decisione, era stata effettuata dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e che la utilizzabilità e ritualità della stessa, attinente alla relazione investigativa, si desumeva implicitamente dalla stessa motivazione di prime cure, non richiedendosi un provvedimento ad hoc per la relativa acquisizione.
3. Tanto premesso, il giudice d’appello, esclusa la tardività della contestazione e dell’irrogazione del provvedimento espulsivo, ha ritenuto che i fatti oggetto di addebito avevano trovato pieno conforto nelle risultanze processuali dalle quali era emerso lo svolgimento sistematico da parte del M.G., durante il periodo di congedo parentale, di attività lavorativa remunerata (consistente nella compravendita di automobili da parte della (OMISSIS) SRL della quale il M.G. era amministratore unico); lo svolgimento di tale attività, né saltuaria, né episodica, si poneva in contrasto con le finalità del congedo parentale retribuito le quali postulano che durante la sua fruizione, i tempi e le energie del padre lavoratore siano dedicati, anche attraverso la propria presenza, al soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore. La condotta del dipendente si configurava quindi quale abuso del diritto al congedo parentale per sviamento della relativa funzione e giustificava l’adozione della sanzione espulsiva venendo in rilievo un comportamento che oltre che contrario ai principi di correttezza e buona fede, era connotato da evidente disvalore, anche sociale.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.G. sulla base di sei motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Parte ricorrente ha formulato richiesta di “oscuramento”.
6. Il P.G. ha depositato memoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.
2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010 e dell’art. 2 della licenza del 10.9.2018 rilasciata dalla Prefettura Provinciale di Roma alla (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., agenzia investigatrice alla quale (OMISSIS). S.P.A. aveva conferito l’incarico; deduce, inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 134 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
2.1. Si duole che la Corte di appello, nel ritenere rispettate le richiamate disposizioni, non avesse tenuto conto: a) della prescrizione contenuta nell’art. 2 della licenza rilasciata alla (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l che obbligava il legale rappresentante della società a svolgere personalmente l’attività oggetto di autorizzazione di polizia, con espresso divieto di impiegare collaboratori; b) dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il collaboratore e la società, per cui le operazioni investigative erano state svolte da un soggetto privo di autorizzazione, con violazione dell’art. 134 TULPS ; c) della nullità della relazione investigativa, in assenza di un incarico scritto conferito da (OMISSIS) S.P.A ; evidenzia che l’incarico mancava di chiarezza nel suo contenuto e questo non consentiva di verificare la legittimità dell’accertamento posto in essere dall’agenzia; d) dell’art. 1 della licenza che autorizzava l’esercizio dell’attività investigativa per l’individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale ai sensi dell’art. 134 TULPS, art. 222 d. lgs. n. 271/1989, art. 5 d.m. n. 26/2010.
3. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la acquisizione della documentazione asseritamente tardiva prodotta dalla società; sostiene che il giudice di prime cure non aveva mai adottato un provvedimento di autorizzazione al deposito né esercitato a riguardo i poteri ex art. 421 c.p.c. ed evidenzia di essere stato leso nell’esercizio del proprio diritto di difesa.
4. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 604/1966 in punto di ripartizione dell’onere della prova del licenziamento; assume che la parte datoriale, onerata, non aveva offerto dimostrazione dello svolgimento da parte del M.G. di attività lavorativa nell’intero periodo di congedo parentale posto che la relazione investigativa aveva riguardato solo quattro giorni rispetto all’intero periodo di fruizione del beneficio, di durata molto maggiore.
5. Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. per violazione del principio di proporzionalità nell’individuazione della sanzione applicabile, e degli artt. 74 e 76, comma 2 c.c.n.l. (OMISSIS) e dell’art. 2119 c.c.; ascrive alla Corte di merito di non avere considerato al fine della valutazione di proporzionalità che la condotta addebitata era riconducibile a fattispecie punite con sanzione conservativa secondo quanto evincibile dagli artt. 74 e 76 c.c.n.l.. Denunzia inoltre la carenza di valutazione dei profili oggettivi e soggettivi della condotta addebitata.
6. Con il quinto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d. lgs. n. 151/2001, con riferimento alla corretta modalità di utilizzo del congedo ivi previsto; in particolare si duole della violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità la quale non richiede la rigida sovrapponibilità temporale tra permesso e tempo di lavoro non svolto.
7. Con il sesto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c. censurando la mancata compensazione delle spese di lite, che assume giustificata dalla oggettiva complessità della vicenda.
8. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
8.1. La sentenza impugnata ha ritenuto fondati gli addebiti ascritti al lavoratore sulla base delle conclusioni della relazione dell’agenzia investigativa, confermate in giudizio dalla deposizione dell’autore dell’indagine il quale fintosi allora un cliente della concessionaria presso la quale operava il M.G., aveva riferito di avere appurato tutte le circostanze segnalate nel documento; la Corte di merito ha precisato che tali univoche risultanze, documentali ed orali, non risultavano smentite dalle deposizioni di altri testi legati al M.G. da rapporti amicali o di parentela (sentenza, pag. 4).
8.2. Quanto ora osservato rende già in astratto prive di concreto rilievo ai fini di causa le deduzioni formulate dall’odierno ricorrente in relazione alle modalità di conferimento ed al contenuto dell’incarico agenziale ed alle asserite violazioni delle prescrizioni della licenza per lo svolgimento dell’attività investigativa, attenendo le stesse rispettivamente al piano dei rapporti con (OMISSIS) S.P.A. e dei rapporti con l’autorità amministrativa, piani estranei all’accertamento alla base del decisum in punto di effettivo svolgimento da parte del M.G. dell’attività professionale in contrasto con le finalità del congedo parentale. Invero, una volta riscontrato che tale accertamento riposa su quanto riferito, per diretta conoscenza, da parte del collaboratore dell’agenzia, escusso quale teste, a conferma delle risultanze della relazione investigativa, lo stesso non potrebbe comunque essere inficiato da eventuali vizi o carenze in tesi verificatisi nel rapporto tra (OMISSIS) S.P.A. e l’agenzia investigativa o tra quest’ultima e la autorità amministrativa.
9. Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
9.1. Premesso che non è configurabile alcuna nullità nella relazione dell’agenzia investigativa in ordine alla dedotta omessa indicazione in essa degli estremi dell’autorizzazione prefettizia, si rileva che le censure in punto di rituale acquisizione, ex art. 421 c.p.c. della documentazione relativa all’agenzia, risultano assorbite dalla considerazione della inidoneità di eventuali carenze sul piano amministrativo ad inficiare la valenza probatoria degli elementi sulla base dei quali i giudici di merito hanno ritenuto accertato il fatto addebitato.
10. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto, a differenza di quanto assume parte ricorrente, la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in contrasto con il criterio di distribuzione dell’onere della prova sancito dall’art. 5 l. n. 604/1966 che pone a carico della parte datoriale la dimostrazione della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento.
10.1. La controversia è stata infatti decisa sulla base delle emergenze in atti alla stregua delle quali la Corte di merito, confermando la valutazione di prime cure, haritenuto dimostrato il fatto ascritto, rappresentato dallo svolgimento, nel periodo di fruizione del permesso ex art. 32 d. lgs. n. 151/2001, di attività lavorativa di compravendita di autovetture. Parte ricorrente, pur formalmente deducendo violazione e falsa applicazione di norma di diritto, mostra in realtà di criticare le conclusioni attinte dal giudice di merito circa l’espletamento, per l’intero periodo, di attività di compravendita di autoveicoli, in contrasto con le finalità proprie del congedo parentale
10.2. Tanto premesso, si osserva che se è vero che la relazione investigativa aveva avuto ad oggetto solo quattro giornate rispetto all’intero periodo, molto più protratto, di fruizione del congedo parentale, è altresì vero che la Corte di merito è pervenuta all’accertamento contestato sulla base di un ragionamento presuntivo tratto da una serie di elementi (sentenza, pag. 4) convergenti nel senso del carattere sistematico e continuativo dell’attività di lavoro espletata dal M.G..
10.3. Tale ragionamento presuntivo non è validamente incrinato dalla deduzione del vizio denunziato che è estraneo alle concrete modalità di accertamento dell’addebito, dovendo ulteriormente osservarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (ex plurimis, Cass. n. 22366/2021).
11. Il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.
11.1. Premesso che è inammissibile, per difetto di specificità, la censura con la quale si deduce la riconducibilità della fattispecie in esame ad ipotesi sanzionate dal contratto collettivo con misura conservativa, non avendo parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., trascritto in ricorso le richiamate disposizioni del contratto collettivo, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia correttamente sussunto la condotta accertata fra quelle che giustificano il recesso per giusta causa.
11.2. Come noto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte la “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici; la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo “standards” conformi ai valori dell’ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è dunque sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Corte di cassazione (v. tra le altre, Cass. n. 7029/2023, Cass. n. 12789/2022, Cass. n. 7426/2018, Cass. n. 31155/2018, Cass. n. 25144/2010).
11.3. La condotta accertata, oltre a costituire grave violazione del dovere di fedeltà gravante ex art. 2105 c.c. sul lavoratore, si connota per il suo particolare disvalore sociale alla luce delle specifiche finalità in relazione alle quali è modulato l’istituto del congedo parentale ed ai sacrifici e costi organizzativi che impone alla parte datoriale a fronte dell’esercizio di tale diritto potestativo da parte del titolare.
11.4. Il congedo parentale disciplinato dall’art. 32 d. lgs. n. 151/2001 si pone, infatti, l’obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell’assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione nel senso che a quest’ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla; come evidenziato da alcuni interpreti, l’art. 32 cit. non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ed è proprio la compressione della iniziativa datoriale lato sensu intesa ed il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale a giustificare una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell’istituto ed in un utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di finalità ad esso del tutto estranee.
11.5. Né la condotta del lavoratore può ritenersi “scriminata“ dalla considerazione che comunque l’attività professionale svolta non impediva al M.G. la cura e l’assistenza del minore, posto che tale affermata compatibilità doveva allora ritenersi sussistente anche in relazione all’attività svolta per (OMISSIS) S.P.A. in tal modo venendo meno in radice la ragione giustificativa dell’istituto.
12. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione.
12.1. La sentenza non ha affatto affermato che vi dovesse essere rigida sovrapponibilità temporale tra permesso e tempo di lavoro ma, con accertamento di fatto istituzionalmente devoluto al giudice di merito e non più rivedibile in questa sede per la preclusione da <<doppia conforme>> ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., ha ritenuto che lo svolgimento di attività lavorativa di compravendita di autovetture fosse in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo parentale.
12.2. Le conseguenze tratte sul piano giuridico dall’accertamento fattuale operato dalla sentenza impugnata sono coerenti con gli approdi di questa Corte sul generale tema della fruizione di permessi per l’assistenza a disabile e su quello, specifico, relativo alla fruizione del congedo parentale, avendo il giudice di legittimità chiarito che l’art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere – in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 – che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale un’indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia. (Cass. n. 509/2018 e giurisprudenza citata). In altri termini la Corte di merito ha reso un accertamento globale circa la incompatibilità dell’attività lavorativa espletata con la funzione del congedo e tanto assorbe il tema, più propriamente connesso alle ipotesi di permessi giornalieri, relativo alla sovrapponibilità periodo di assistenza / orario lavorativo.
13. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 8421/2017, Cass. 15317/2013) .
14. Infine, non si ravvisano i presupposti per accogliere la richiesta di oscuramento formulata dal ricorrente dato il tenore delle questioni affrontate e la assoluta genericità delle deduzioni alle quali è stata affidata la richiesta in oggetto.
15. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna di parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso […]”.
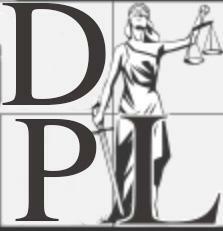
Commenti recenti