Licenziamento disciplinare: irragionevole il reintegro solo per fatti tipizzati dai contratti collettivi.
Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza interlocutoria n. 14777/2021Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza interlocutoria 27 maggio 2021, n. 14777.
Licenziamento disciplinare: la tutela reintegratoria solo in casi di condotte tipizzate dal CCNL è irragionevole.
di Luigi Verde
1. Con ordinanza interlocutoria n. 14777, del 27 maggio 2021, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ha disposto la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro affermando che l’orientamento assunto dalla stessa Corte circa l’interpretazione dell’art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, presenta profili di irragionevolezza laddove individua il discrimine tra la tutela reintegratoria, di cui al cit. comma 4, art. 18, e quella indennitaria di cui al comma 5, dell’art. 18, in base al dato della coincidenza del fatto addebitato con una specifica fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa.
2.Con la suddetta ordinanza, la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione [1] ha rimesso dunque alla Sezione Lavoro la decisione in merito alla tutela applicabile nel caso di un licenziamento disciplinare ritenuto sproporzionato rispetto a una condotta che non risultava specificamente elencata dal CCNL applicato tra quelle punibili con sanzione conservativa. Nella versione modificata dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (impropriamente “legge Fornero”), l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ai commi 4 e 5 prevede, in caso di licenziamento disciplinare ingiustificato, una duplice possibile tutela: a) reintegratoria e indennitaria, se il giudice accerta l’insussistenza del fatto contestato o che questo rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del contratto collettivo o del codice disciplinare; b) meramente indennitaria negli altri casi. Il più recente orientamento della Corte riduce l’ambito della previsione delle “condotte punibili con una sanzione conservativa…” alle sole ipotesi in cui il contratto collettivo o il codice disciplinare del datore di lavoro abbiano tipizzato i casi punibili con la sanzione conservativa, delineandone tutti gli elementi costitutivi. La Sezione Sesta della Corte (cui è demandata la pronuncia su questioni sulle quali la Corte si è ormai pronunciata in maniera uniforme, ma che può dissentirne rimettendo la questione alla Sezione lavoro ordinaria), investita del giudizio in cui erano appunto in gioco le conseguenze di un licenziamento per giusta causa ingiustificato, fa rilevare l’irrazionalità dell’orientamento recente, in ragione del fatto che i contratti collettivi solo raramente “tipicizzano” le ipotesi disciplinari, utilizzando invece, quanto meno come norma di chiusura, formule generiche (inadempimento lieve e grave, negligenza lieve etc.). Inoltre i contratti collettivi non decidono se tipizzare o usare formule generiche in funzione della disciplina di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ciò sarebbe assurdo, laddove a redigere il codice disciplinare fosse solo e unilateralmente il datore di lavoro. Infine, secondo la Corte, appare discriminatorio trattare diversamente ipotesi tipizzate e altre che hanno, nell’intenzione delle Parti collettive o del datore di lavoro, identica rilevanza disciplinare, e però espresse con formule riassuntive, e generiche. Nel rimettere la questione alla Sezione lavoro, la Sesta Sezione ha sollecitato una riflessione critica sull’orientamento che esclude la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Stat. Lav. quando il CCNL non preveda espressamente la condotta tra quelle meritevoli di sanzione conservativa senza che, a tal fine, possa farsi riferimento a clausole generali quali “mancanze di lieve entità”.
3.I fatti. Una società operante nel settore della vigilanza intimava ad un proprio dipendente, che svolgeva il ruolo di comandante delle guardie giurate, il licenziamento per giusta causa sulla base dei seguenti addebiti: a) critiche e denigrazioni mosse dal dipendente ai responsabili dell’impresa in una conversazione via chat con una collega; b) omessa denuncia dell’aggressione subita da una guardia giurata durante il servizio; c) omessa segnalazione, durata cinque mesi, alla Questura di Udine dei turni di servizio del personale.
Dopo il primo grado, la Corte d’Appello di Trieste dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi del comma 5, art. 18, St. lav. In particolare, la Corte, accertata l’irrilevanza disciplinare della prima contestazione e il “minimo rilievo” degli altri due addebiti, esaminava l’art. 101 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di vigilanza privata, rilevando la difficoltà a ricondurre il caso concreto alle fattispecie disciplinari previste dalle Parti stipulanti in quanto “formulate in modo assai generico e indefinito”[2]. A sostegno della propria decisione la Corte d’Appello richiamava la tesi della natura tendenzialmente residuale della tutela reale nonché l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “solo ove il fatto contestato ed accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria”, prevista dal vigente comma 4 dell’art. 18, St. Lav..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore, mentre il datore di lavoro resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
4.L’ordinanza. La questione riguarda l’interpretazione e l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 18 St. lav. con riferimento al ruolo dei codici disciplinari, soprattutto quelli concordati in sede collettiva, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria oppure di quella indennitaria. L’ordinanza interlocutoria qui al nostro esame da conto anche del diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui è imprescindibile, ai fini dell’applicazione della tutela reale di cui al comma 4 dell’art. 18, St. lav., l’analitica tipizzazione da parte del codice disciplinare dell’inadempimento suscettibile di sanzione conservativa. Secondo questa interpretazione, l’unico giudizio di proporzionalità consentito ai sensi del comma 4, art. 18, sarebbe quello effettuato ex ante dalle stesse Parti collettive attraverso l’esatta e specifica individuazione di inadempimenti ritenuti meritevoli di sanzione conservativa.
In particolare, a partire dalla sentenza n. 12365 del 2019, del 9 Maggio 2019, seguita da varie pronunce conformi, la Cassazione ha affermato che la tutela reale di cui al comma 4 dell’art. 18, presuppone una valutazione di proporzionalità fra provvedimento disciplinare e fatto contestato tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il contratto collettivo rimetta al giudice la valutazione dell’esistenza di questa proporzionalità, al lavoratore spetta solo la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell’art .18.
4.1.Al riguardo, la Sesta Sezione della Cassazione, con l’ordinanza 27 maggio 2021, n. 14777, qui al nostro esame, esprime perplessità in relazione all’orientamento della Sezione Lavoro che, in nome dell’esigenza dell’impresa di prevedere i costi del licenziamento illegittimo, individua il discrimine tra tutela reale e quella indennitaria nella tipizzazione degli illeciti ad opera dei contratti collettivi o dei codici disciplinari, escludendo altresì la possibilità di interpretazione giudiziale delle clausole generali e comprimendo lo spazio di interpretazione estensiva delle norme disciplinari. In altre parole, la Sesta Sezione invita a riflettere sul fatto che non si si tenga debitamente conto della distinzione tra giudizio di proporzionalità e attività di sussunzione, interpretazione e applicazione delle norme collettive e quindi sulla irragionevolezza dei suoi esiti.
4.2.La Cassazione afferma dunque che in presenza di fattispecie punite con misure conservative e descritte attraverso clausole generali, l’attività compiuta dal giudice ha come oggetto l’interpretazione della fonte negoziale e la sussumibilità del fatto contestato nella disposizione contrattuale, ed implica un giudizio di diritto che compete al giudice di merito e, in modo diretto (a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ad opera del D.lgs. n. 40/2006), anche al giudice di legittimità. Il vizio di sussunzione di cui al cit. art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. è ipotizzabile anche nel caso di norme (anche contrattuali) che contengano clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Da ciò consegue che l’attività di sussunzione della condotta contestata al lavoratore nella previsione contrattuale espressa attraverso clausole generali “non trasmoda nel giudizio di proporzionalità” della sanzione rispetto al fatto contestato, ma si arresta alla interpretazione ed applicazione della norma contrattuale, rimanendo nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti collettive.
Il giudice non effettua un’autonoma valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto, ma interpreta il contratto collettivo e lo applica alla fattispecie concreta. Il suo compito è stabilire, ad es., se una determinata condotta sia sussumibile nella nozione giuridica di negligenza lieve, e non consiste nel decidere se per la condotta di negligenza lieve sia proporzionata la sanzione conservativa o quella espulsiva.
La circostanza che alcune condotte non risultino tipizzate dai contratti collettivi come suscettibili di sanzioni conservative, specie in presenza di formule generali o aperte oppure di norme di chiusura, non può costituire un indice significativo e plausibile della volontà delle parti collettive di escludere tali condotte dal novero di quelle meritevoli delle sanzioni disciplinari più blande, cioè conservative. In primo luogo perché la tipizzazione di alcune condotte non è concepita dalle parti collettive in funzione della distinzione che l’art. 18 pone, ai commi 4 e 5, tra la tutela reale e la tutela obbligatoria. In secondo luogo perché la tipizzazione non è realizzata secondo un criterio idoneo a dare ragione del fatto per cui solo alcuni illeciti disciplinari, e non altri, meritino la tutela reintegratoria. La tipizzazione, in altri termini, non ha un “nesso eziologico e valoriale” rispetto alla funzione di discrimine che viene ad essa attribuita. Con la conseguenza, irragionevole, di far ricadere sui lavoratori le lacune e la approssimazione della disciplina contrattuale collettiva.
4.3. L’ordinanza precisa insomma che l’attività di sussunzione della condotta contestata nell’una o nell’altra norma collettiva contenente clausole generali non si risolve in un giudizio di proporzionalità delegato alle parti sociali, ma riguarda solo l’interpretazione della norma contrattuale e la sua applicazione alla fattispecie concreta. In altri termini, in questi casi, il giudice non compierebbe un’autonoma valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto ma si limiterebbe a stabilire se una determinata condotta sia sussumibile, o no, nella nozione, ad esempio, di “negligenza lieve” contenuta nella norma collettiva.
In secondo luogo, il più recente orientamento giurisprudenziale viene criticato perché individuerebbe in modo irragionevole il discrimine tra tutela reale di cui al comma 4 e la tutela obbligatoria di cui al comma 5 dell’art. 18 in base al mero dato della coincidenza del fatto contestato con una specifica fattispecie punita con sanzione conservativa dal codice disciplinare e, quindi, in definitiva, in base alla più o meno analitica tipizzazione degli illeciti disciplinari ad opera dei contratti collettivi o addirittura dallo stesso datore di lavoro. Senonché, continua la Sesta Sezione, in materia disciplinare, diversamente dalla materia penale, il principio di tassatività non opera in modo rigoroso perché vi è una sostanziale indeterminatezza degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, che comporta in pratica l’impossibilità di tipizzare in modo analitico tutte le condotte disciplinarmente rilevanti: tant’è che i codici disciplinari ricorrono sempre a clausole generali e a norme di chiusura.
Secondo l’ordinanza qui al nostro esame, alla mancata tipizzazione di specifiche condotte non consegue necessariamente che le Parti collettive abbiano ritenuto le menzionate condotte non meritevoli di sanzione conservativa, anche perché la formulazione dei codici disciplinari non viene concepita in funzione della distinzione tra tutela reale e tutela obbligatoria, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 18; appare pertanto irragionevole “far ricadere sui lavoratori le lacune e la approssimazione della disciplina contrattuale collettiva”.
Infine, la valorizzazione della tipizzazione come “discrimen” rischia di provocare, ad avviso della Sesta Sezione, una sorta di “eterogenesi dei fini”: il ricorso alle clausole generali da parte dei codici disciplinari, invece di garantire una parità di trattamento, condurrebbe di converso ad una disparità di tutela laddove la condotta contestata, pur avendo pari o minore rilevanza disciplinare, non rientri nelle fattispecie tipizzate dalla norma collettiva.
La questione dev’essere quindi esaminata dalla Sezione Quarta, cui spetta di compiere una “ulteriore riflessione” sulla portata dell’art. 18, commi 4 e 5, e, in particolare, sull’orientamento in via di consolidamento in seno alla stessa Sezione della Corte di Cassazione. L’alternativa sembra sospesa tra un revirement giurisprudenziale e una nuova questione di legittimità costituzionale sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
NOTE
[1] Alla Sesta Sezione della Corte di Cassazione è, come noto, demandata la verifica preliminare prevista dall’art. 376, comma 1, c.p.c. al fine di valutare se sussistono i presupposti per una pronuncia in camera di consiglio (ordinanza di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso ex art. 375, comma 1 c.p.c.). Nel caso in cui non ravvisi tali presupposti, la Sesta Sezione rimette gli atti alla sezione semplice competente per materia.
[2] L’art. 101 del CCNL Vigilanza privata (Istituti), benché costituisca, per espresso riconoscimento delle parti firmatarie, il c.d. “codice di disciplina” di cui all’art. 7 St. lav., si limita a prevedere le seguenti sanzioni conservative per le seguenti fattispecie disciplinari: il “rimprovero scritto” per le condotte caratterizzate da “lievi irregolarità” nell’adempimento (lett. A); la “multa” per i casi di ritardo nell’inizio del lavoro e di esecuzione della prestazione “senza la necessaria diligenza” (lett. B); la “sospensione” per i casi di “negligenza grave” o di omissione parziale nella esecuzione del lavoro (lett. C).
[1] Centro Studi Livatino, 7 agosto 2020. Interni. Titolo originale: “Taglio dei parlamentari: una riforma settoriale e rischiosa” (www.centrostudilivatino.it)
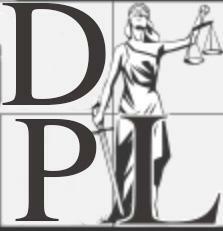
Commenti recenti