(Fonte: Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea- ILSREC)
“La Resistenza ‘Taciuta’
Guerriere silenziose, le donne in migliaia hanno preso parte alla Resistenza, offrendo un significativo contributo. Si constata che solo una minima parte di esse ha avuto il meritato “riconoscimento”. E anche i numeri riportati sui documenti ufficiali tendono a essere solo in parte veritieri, perché migliaia, infatti, sono le partigiane destinate a rimanere nell’anonimato, forse perché ritenute poco importanti. Arrivate a ricoprire il proprio ruolo attraverso vie diverse, le donne, nonostante un certo scetticismo maschile, hanno fatto la loro parte.
Secondo Ada Prospero Gobetti (vedova di Piero -martire del primo antifascismo italiano- e medaglia d’argento al valore militare per la sua partecipazione alla lotta di liberazione), “nella Resistenza la donna fu presente ovunque: sul campo di battaglia come sul luogo di lavoro, nel chiuso della prigione come nella piazza o nell’intimità della casa. Non vi fu attività, lotta, organizzazione, collaborazione a cui ella non partecipasse: come una spola in continuo movimento costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile il tessuto sotterraneo della guerra partigiana” (Diario partigiano, Torino, Einaudi, 1956).
Riportiamo alcuni dati, relativi alla presenza delle donne nella Resistenza, forniti dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) e ripresi anche da Donatella Alfonso in Ci chiamavano libertà. Partigiane e resistenti in Liguria 1943-1945 (Genova, De Ferrari, 2012, II ediz. ampliata 2013):
35.000 combattenti
20.000 patriote
70.000 nei Gruppi di difesa della donna (v. più sotto)
4653 arrestate
2812 impiccate o fucilate
2750 deportate nei campi di sterminio
1070 cadute in combattimento
891 (di cui 112 in Liguria) deferite al Tribunale Speciale nel corso di diciassette anni di attività
19 medaglie d’oro
17 medaglie d’argento
Donatella Alfonso nella sua opera sostiene, tuttavia, che i calcoli degli esperti militari facciano salire ad almeno un milione il numero delle donne impegnate, a vario titolo, nella rete della Resistenza. Eppure soltanto in anni recenti si è iniziato a mettere a fuoco tale partecipazione, con studi e pubblicazioni specifiche. A questo proposito annota la storica Anna Bravo: “le giovani partigiane sono preziose, hanno il talento dell’iniziativa, padroneggiano il territorio, sanno mimetizzarsi e vestirsi, passano (si spera, passino) più facilmente ai posti di blocco”.
La partecipazione femminile alla Resistenza fu, inoltre, un fenomeno quasi esclusivamente collettivo: come ha osservato Ada Gobetti, “caratteristica fondamentale della Resistenza femminile, che fu uno degli elementi più vitali della guerra di liberazione, è proprio questo suo carattere collettivo, quasi anonimo, questo suo avere per protagoniste non alcune creature eccezionali, ma vaste masse appartenenti ai più diversi strati della popolazione, questo suo nascere non dalla volontà di poche, ma dall’iniziativa spontanea di molte”.
L’accettazione delle donne, da parte maschile, non fu facile. Inizialmente molti compiti a loro affidati rientravano nella sfera del cosiddetto maternage, ovvero in attività ritenute dalla società del tempo tipiche della donna e consone alla sua “natura” quali il cucinare per le brigate partigiane e il prendersi cura dei feriti e dei malati; alcune affermano di essersi sentite talvolta madri e sorelle, poiché i loro compagni partigiani confidavano a loro le proprie preoccupazioni e paure. Compiti ancora più importanti e rischiosi erano quelli legati al ruolo di staffette (si veda più sotto), incarico di grande importanza per la trasmissione di informazioni e consegna di materiali affidato spesso a giovani ragazze proprio perché “avrebbero dato meno nell’occhio”.
Prima ancora che nasca la Resistenza le donne furono protagoniste degli scioperi del 1943. Il fascismo aveva esaltato i compiti esclusivamente domestici della figura femminile ma, con l’entrata in guerra, le donne acquisirono un ruolo di primo piano nelle fabbriche e nei servizi pubblici. A causa della partenza degli uomini per il fronte, dei bombardamenti, degli sfollamenti e dello sfruttamento in fabbrica (le donne, a parità di mansioni, erano pagate la metà degli uomini, benché svolgessero anche il lavoro notturno e turni di 12 ore), l’esasperazione nel marzo 1943 era sul punto di esplodere: “si preparava – ricorda la partigiana Anna Fenoglio – lo sciopero contro la guerra, per i prezzi, per i cottimi individuali, contro le dodici ore, perché eravamo stufe e basta”. Forte, negli scioperi del 1944, risultò la presenza femminile e spesso furono proprio le donne a indurre gli uomini alla sospensione del lavoro.
Nel novembre del 1943 nacquero a Milano i Gruppi di difesa della donna (GDD), su iniziativa di donne del PCI (Rina Piccolato, Giovanna Barcellona, Lina Fibbi), del Partito d’Azione (Ada Gobetti) e del PSI (Lina Merlin). A Genova si costituirono agli inizi del 1944, ad opera di Elettra Prampolini ed Edera Batini.
Il lavoro dei GDD consisteva nell’assistenza in varie forme ai partigiani, aiuto economico alle famiglie dei deportati e dei combattenti, organizzazione di sabotaggi, attività di propaganda, raccolta di fondi.
Con il passare dei mesi e il progressivo affermarsi della Resistenza, le donne vennero a ricoprire una pluralità di mansioni quali staffette, infermiere, vivandiere, cucitrici, ricercatrici di finanziamenti, stampatrici di giornali, amministratrici di denaro destinato al movimento, offrendo anche la disponibilità a nascondere uomini per sottrarli al lavoro coatto o all’arruolamento nelle milizie di Salò.
Le donne non ebbero quindi una particolare specializzazione, si occuparono, possiamo dire, di tutto, anche di combattere con le armi un pugno.
Staffette
Il compito più caratteristico, e unico ad essere stato sostanzialmente riconosciuto, delle donne nella Resistenza è stato quello di staffetta: un ruolo che si distanzia dall’immagine tradizionale della donna impegnata in attività tra le mura domestiche (cura dei feriti, confezione degli abiti ecc.) ma che non coincide neppure con la lotta armata.
Il termina staffetta allude ai numerosi passaggi di mano dei messaggi da loro portati. Il loro numero fu molto alto e nella sola Firenze, per fare un esempio, ne furono censite circa 400.
La loro attività sarebbe stata impensabile prima della guerra, perché presupponeva una notevole libertà di movimento, sia per le nubili che per le sposate: le staffette potevano viaggiare anche per diversi giorni, pernottando in qualche cascinale, e i continui spostamenti a piedi, in bicicletta, talora in treno o con mezzi di fortuna erano giustificati, agli occhi dei genitori o dei vicini di casa, con la necessità di trovare qualcosa da mangiare nelle campagne.
Le staffette sapevano di correre il rischio di essere imprigionate, di subire possibili violenze e, in ultima analisi, di perdere la vita. Di seguito elenchiamo alcune norme di comportamento, evidenziate dalla storica Marina Addis Saba, che le staffette dovevano attentamente seguire:
– non dovevano far conoscere a nessuno il loro compito e la loro provenienza;
– nella casa in cui vivevano dovevano far credere di svolgere un lavoro normale;
– dovevano avere sempre una giustificazione pronta nel caso fossero state fermate durante il viaggio;
– dovevano essere sempre puntuali agli appuntamenti;
– dovevano assicurarsi di non essere seguite;
– se si fossero accorte di essere seguite da qualcuno non dovevano presentarsi all’appuntamento;
– dovevano informare subito il dirigente partigiano se fosse accaduto loro qualche incidente;
– dovevano nascondere il materiale nel modo migliore e camminare con disinvoltura;
– quando consegnavano il materiale non dovevano rivelare ciò che avevano portato.
Si usava di tutto per nascondere i messaggi da recapitare, persino giarrettiere, reggiseni, calze, pancere; da una testimonianza sappiamo che una donna, di un paesino sulle alture di Genova, trasportava i suoi biglietti nascondendoli tra i capelli in uno chignon.
Oltre ai messaggi le staffette potevano portare cibo, vestiario, medicine, armi, ricetrasmittenti e avevano spesso il compito di spiare i movimenti dei tedeschi e dei fascisti e di tenere i collegamenti tra le formazioni di montagna e i partigiani operanti in città.
Alcune di loro erano poco più che bambine, come la futura giornalista e scrittrice Oriana Fallaci che, figlia di un padre partigiano, a soli 13 anni faceva la staffetta, portando copie di giornali e accompagnando ex prigionieri anglo-americani verso le linee alleate. La più giovane staffetta uccisa dai tedeschi risulta essere Ada Marongiu, del gruppo di GL in val Maira, fucilata a 18 anni a Dronero, in provincia di Cuneo.
“Fattorine”
Erano soprattutto donne a organizzare e diffondere la stampa clandestina. Il giornale più diffuso era “Noi donne” ma numerosi fogli nascevano un po’ ovunque. Raramente, però, le donne scrivevano: il loro compito consisteva soprattutto nel raccogliere i testi scritti dai partigiani, portarli in tipografia, ritirare i giornali, fogli, volantini e diffonderli con il “porta a porta” la mattina presto, distribuirli nelle piazze, stazioni, mercati (magari con comizi volanti), fabbriche.
Infermiere
Le donne assistevano i partigiani feriti e i malati negli ospedali pubblici o in centri di pronto soccorso da loro creati e gestiti.
Renata Viganò, autrice del romanzo L’Agnese va a morire (1949), seguì il marito e il figlio nella Resistenza, dirigendo il servizio sanitario della brigata che operava nelle valli di Comacchio.
Partigiane combattenti
Furono circa 35.000, cifra che può apparire modesta rispetto al totale dei partigiani combattenti (circa 235.000) ma che va contestualizzata, pesando notevolmente la differenza tra i due sessi: gli uomini avevano conosciuto l’addestramento e la vita militare e questo fece sì che per loro potesse essere “quasi normale” entrare nelle formazioni partigiane e imbracciare un’arma. Inoltre se per molti maschi la lotta partigiana fu una scelta dettata spesso dalla necessità di evitare i bandi di arruolamento per l’esercito di Salò o di sfuggire a probabili arresti, retate, deportazioni in Germania come lavoratori coatti, questo non si verificò per le donne.
Alcune diventarono combattenti per seguire il marito, il fratello, il fidanzato. Il reclutamento, sia per le staffette che per le combattenti, avveniva spesso tramite i GDD. Una volta accolte nelle formazioni vigeva però la parità: le donne avevano gli stessi compiti degli uomini, dai turni di guardia alla pulizia delle armi e ai combattimenti.
Nonostante ciò, le resistenze mentali maschili restarono notevoli. In val d’Ossola, durante i quaranta giorni della repubblica, votavano solo i capofamiglia, non le donne.
La presenza femminile non mancò neppure nei GAP, formazioni operanti in ambito cittadino dedite ad attentati nei confronti degli esponenti dell’esercito tedesco e della RSI.
Molte furono le donne che subirono torture e violenze sessuali, tragiche esperienze di cui preferirono non parlare a guerra conclusa. Molte furono deportate nei lager nazisti, in prevalenza in quello di Ravensbrück, specificamente destinato alle prigioniere, ove vennero utilizzate come manodopera coatta per le esigenze belliche tedesche”.
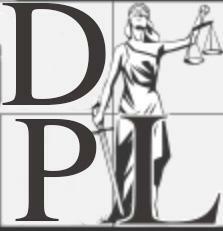
Commenti recenti