Nota a cura di Luigi VERDE.
1. La conciliazione giudiziale è un istituto previsto dall’art. 185 c.p.c. (ma v. art. 420 c.p.c., segnatamente per il rito del lavoro) che consente alle parti, grazie all’intervento del giudice, di comporre la lite addivenendo ad una convenzione. La norma suddetta stabilisce che il giudice è tenuto a disporre la comparizione personale delle parti e alla fissazione di un’udienza ad hoc qualora le parti congiuntamente lo richiedano al fine di interrogarle e di provocarne la conciliazione.
2. Secondo una consolidata opinione, la conciliazione giudiziale è un atto negoziale trilaterale in quanto l’accordo tra le parti viene raggiunto grazie all’intervento di un terzo, il giudice, e viene formalizzato in un atto avente – quantomeno – la “forza” giuridica di atto pubblico. La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185-185 bis c.p.c., pur richiedendo sempre una convenzione, non sia tuttavia assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, con l’ordinanza di cancellazione dal ruolo e l’estinzione “sui generis” del processo, e, dall’altro lato, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, il quale resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria ( (Cass. Civ., n. 11677/1995, Trib. Roma 20/3/2018).
Invero, più recentemente la S.C. (Cass. 30 settembre 2020, ordinanza n. 20913), proprio in relazione alla conciliazione giudiziale, precisa –sotto un diverso angolo di visuale- che al relativo verbale non possono essere attribuiti effetti equiparabili a quelli di una sentenza passata in giudicato, configurandosi piuttosto un titolo di natura contrattuale, il quale, in questo senso, resta pertanto soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità.
La transazione contenuta in una conciliazione giudiziale è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all’art. 2113 c.c., conservandosi le azioni -con la relativa disciplina- di nullità e di annullamento del contratto.
L’intervento del giudice, infatti, non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva.
Relativamente ai diritti già maturati il negozio integra sostanzialmente una transazione, trovando applicazione quanto disposto dall’art. 2113 in materia di norme inderogabili (annullabilità). Rispetto, invece, ai diritti non ancora sorti o maturati, la preventiva disposizione può comportare la nullità dell’atto, essendo esso diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro con modalità differenti rispetto a quelle fissate in sede legale o di contrattazione collettiva.
3. Alcune considerazioni di ordine pratico sul verbale di conciliazione di cui all’art. 420 c.p.c.[1]
Quanto al contenuto del verbale di conciliazione, questo deve certamente contenere:
a) l’indicazione dell’oggetto della lite e una sintesi delle domande;
b) la manifestazione dell’intenzione di conciliare e le condizioni della conciliazione, con l’indicazione degli importi al lordo;
c) la rinuncia alle domande e al giudizio;
d) la disciplina delle spese e la rinuncia alla solidarietà professionale.
Relativamente alle spese, la riforma di cui al Decreto ministeriale 147/2022, che ha modificato il Decreto 55/2014, specificamente all’art. 4 comma 6), ha previsto che nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.
Riguardo al contenuto del verbale, le parti sono libere di strutturarlo come meglio ritengono, ferma restando una verifica finale di liceità da parte del giudice, anche con riguardo alla tutela di diritti indisponibili (ad esempio, non potrebbe essere inserita in un verbale di conciliazione una pattuizione in virtù della quale, a chiusura di una lite, una lavoratrice accetta una somma rinunziando ai permessi parentali).
È importante ricordare che il verbale di conciliazione giudiziale ha efficacia di titolo esecutivo.
Un aspetto specifico è quello della necessità della procura speciale di cui all’art. 185 c.p.c., come alternativa alla presenza personale delle parti per la conciliazione.
La presenza delle parti è comunque preferibile, con lo scopo di renderle pienamente edotte di quanto sta accadendo e delle condizioni che stanno accettando, nonché della rinuncia al giudizio.
In verità questo è anche il motivo che porta a ritenere necessaria o comunque preferibile la procura speciale, piuttosto che a limitarsi al mandato già conferito al difensore, ove la partecipazione personale delle parti non sia possibile.
Infatti, la procura speciale svolge una funzione di trasparenza e di garanzia nei confronti della parte, ma anche a tutela del difensore, sia rispetto alle condizioni della conciliazione, che alla rinuncia al giudizio. Addirittura si rinvengono casi in cui i difensori all’interno della procura speciale inseriscono persino le condizioni della conciliazione, proprio in questa duplice prospettiva, che porta a ritenere ampiamente preferibile l’impiego della procura speciale in caso di assenza delle parti.
Da ultimo, la redazione del verbale di conciliazione è stata semplificata dalla normativa dell’emergenza sanitaria COVID-19. In particolare l’art. 88 comma 2, disp. att. c.p.c. (come modificato dall’art. 3 comma 1-bis del D.L. 30 aprile 2020 n. 28) prevede che, in caso di redazione del verbale di conciliazione giudiziale con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati.
Da un punto di vista pratico, raggiunto l’accordo tra le parti i difensori possono depositarlo in via telematica in un documento in formato PDF, in modo che possa essere trasfuso direttamente dal giudice in un verbale telematico di conciliazione giudiziale.
3. APPENDICE.
3.1. Art. 420 c.p.c.
“Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio . Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima concedendo alle parti ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate”.
3.2. Massime correlate.
Cass. civ. n. 25472/2017. La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall’art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, da un lato per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall’altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, negozio anch’esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità “ad substantiam”, essendo la forma scritta prevista dall’art. 1967 c.c. ai soli fini di prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso di una udienza, per carenza di forma scritta e della relativa sottoscrizione, senza tener conto che il verbale di causa costituiva atto scritto idoneo ai fini probatori).
Cass. civ. n. 4717/2014. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, senza che possa attribuirsi significato di rinuncia o di acquiescenza al fatto di non avere ripetuto l’istanza di ammissione nelle conclusioni di primo grado, in quanto non essendo previste, in detto rito, udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza è destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non può desumere l’abbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di un’ulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima.
[1] Cfr. Ottavia CIVITELLI (Giudice del lavoro presso il Tribunale di Castrovillari), “Una prospettiva sulla conciliazione giudiziale nel rito del lavoro”, in Questione Giustizia, 10 Marzo 2023.
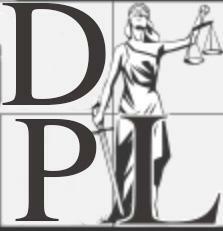
Commenti recenti