Nota di Gianni Arrigo
1.Tre Giugno 2024: cento anni dalla morte di Franz Kafka. Pochi artisti sopravvivono alla spietatezza dell’oblio. La cosa paradossale non è tanto che Franz Kafka non rientri in questa categoria, bensì che proprio all’oblio pensava di essere destinato. Kafka, che ebbe più fortuna dopo la sua prematura morte che in vita.
Nel suo testamento, Kafka aveva chiesto all’amico Max Brod di dare alle fiamme tutti i manoscritti inediti e di impedire nuove edizioni di quelli pubblicati. Brod tuttavia rifiutò di dare corso al desiderio dell’amico e negli anni seguenti pubblicò i tre romanzi inediti (“America”, “Il processo” e “Il castello”), tutti i racconti e frammenti, i diari e gran parte delle lettere.
2..Già negli anni Trenta, ma in forma sempre più imponente nei decenni successivi, la grandezza letteraria di Kafka è stata riconosciuta in tutta Europa.
La sua influenza sulla cultura del Novecento e del nuovo Secolo è incalcolabile.
Franz Kafka, scrittore boemo di lingua tedesca, viene ricordato come un artista capace di influenzare la letteratura e l’immaginario di un mondo intero.
Figlio di un commerciante ebreo, ebbe col padre un rapporto tormentato, documentato nella “Lettera al padre” (1919). Il fidanzamento con Felice Bauer, interrotto, ripreso, poi definitivamente sciolto, e poi la relazione con Dora Dymant, con cui visse dal negli ultimi anni, testimoniano l’angosciata ricerca di una stabilità sentimentale che non fu mai raggiunta[1].
3.Kafka, nato a Praga nel 1883, intraprese gli studi di Giurisprudenza, si laureò nel 1906 e s’impiegò in una compagnia di assicurazioni. Malato di tubercolosi, soggiornò per cure a Riva del Garda (1910-12), poi a Merano (1920) e, da ultimo, nel sanatorio di Kierling, presso Vienna, dove morì.
Praga era, al tempo di Franz Kafka, un vivace centro culturale.Pparticolarmente viva era la presenza della cultura ebraica. Kafka strinse amicizia con Franz Werfel e Max Brod, partecipando alla vita letteraria della città.
Nel 1913 esordì con una raccolta di brevi prose, “Meditazione”.
Nel 1915 pubblicò con l’editore Kurt Wolff, di Lipsia, il suo racconto più celebre “La metamorfosi” (“Die Verwandlung”), storia surreale di un uomo, un commesso viaggiatore che grazie al suo lavoro mantiene la propria famiglia, che, risvegliandosi un mattino nel suo letto, si trova trasformato in un in un enorme insetto immondo (“Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt”).
Inizia così una vicenda surreale, in cui l’inesplicabile orrore è vissuto da tutti i protagonisti con toni di piatta banalità: le preoccupazioni di ordine pratico cancellano l’eccezionalità degli eventi, la realtà quotidiana diventa un dato di fatto e annulla ogni possibile pensiero e riflessione, mentre l’unica cosa davvero importante è mantenere una parvenza di normalità.
Il 1916 è l’anno di “La condanna”. Seguono poi “Nella colonia penale” (1919), “Il medico di campagna” (1919), “La costruzione della muraglia cinese” e quindi i tre romanzi incompiuti: “America” (1924), “Il processo” (1924) e “Il castello” (1926).
4. Si è detto che il vero soggetto kafkiano è l’uomo[2]. Soggetto e cavia, si potrebbe aggiungere, perché sottoposto alla duplice azione di una lente d’ingrandimento che mira a definirne e penetrarne i contorni della personalità.
Un soggetto da mettere alle strette, facendo di ogni romanzo e racconto un terzo grado che lo tenga sotto scacco, se necessario anche barando, come accade a Joseph K. nel “Processo”, il quale che si consuma e dispera nel tentativo di comprendere quale buona ragione possa avere la giustizia per chiamarlo in causa. Kaflka comunica l’inquietudine che scorre sotto la pelle di ogni uomo ogni volta che s’imbatte in una situazione-limite[3]. Una di queste potrebbe essere lo stato di afonia in cui, esaurita l’ultima scorta di belle parole e venuto meno il loro potere consolatorio, potrebbe cadere l’uomo.
È questo il tema di una delle lettere di Kafka. “Io cerco sempre di comunicare qualcosa di non comunicabile, di spiegare qualcosa di inspiegabile, di parlare di ciò che ho nelle ossa e che soltanto in queste ossa può essere vissuto. In fondo non è forse altro che quella paura, della quale si è parlato tante volte, ma paura estesa a tutte le cose, paura delle cose più grandi come delle più piccole, paura, convulsa paura di pronunciare una parola. È vero che questa paura non è forse soltanto paura, ma anche nostalgia di qualche cosa, e ciò è più di tutto ciò che suscita paura[4]”.
Molto si dovrebbe dire su questo artista determinante nella cultura europea (e non solo). L’invito a leggere e rileggere alcuni suoi testi è scontato in questo centenario[5]. Certo, si tratta spesso di scritti ardui e provocatori, ma a questa critica Kafka stesso forse rispondeva con una considerazione presente in una sua lettera del 1903 a Oscar Pollack: “Se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché lo leggiamo? Buon Dio, saremmo felici anche se non avessimo libri e quei libri che ci rendono felici potremmo, a rigore, scriverli da noi. Ciò di cui abbiamo bisogno sono quei libri che ci piombano addosso come la sfortuna, che ci turbano profondamente come la morte di qualcuno che amiamo più di noi stessi, come un suicidio. Un libro deve essere una piccozza per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi”.
[1] Cfr. “Enciclopedia della Letterature”, Garzanti, 2003.
[2] G.Pulina, “Cento anni ben portati di Franz Kafka”, www.leurispes.it.
[3] G. Pulina, “Dizionario di antropologia filosofica”, Diogene Multimedia, Bologna 2022
[4] Kafka, “Lettere”, a cura di F. Masini, Mondadori, Milano 1988, p. 876.
[5] G. Ravasi, “Kafka su un crinale, in “Vita e Pensiero”, 2/2024.
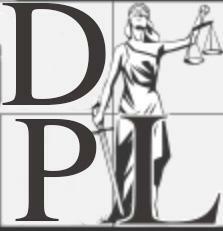
Commenti recenti